Un’indagine intorno al mito antico della Grande Madre.
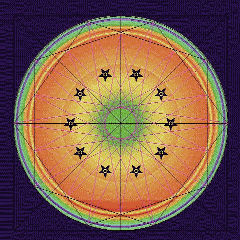 1. Ricorrenza di questo mito La ragione di questa indagine è innanzitutto personale: ho tentato di esplorare la fitta e contorta trama in cui si compone questo argomento esoprattutto ho colto in esso il veicolo di valori universali, vitali, che oggi sembrano inaridirsi nella quotidianità della vita contemporanea: mi riferisco al sentimento sacro e rispettoso di fronte alla via, di fronte alla natura, di fronte alla morte. Che cos'è la Grande Madre? Difficile definire un concetto, un sentimento, che per lo più è antichissimo. Con l'incontro di oggi non arriveremo a definire nulla: tenteremo semplicemente una ricerca augurandoci di stimolare curiosità, domande, interrogativi e di fornire alcuni possibili indirizzi e strumenti di analisi. Poiché, come vedremo, il mito della Grande Madre è un tema complesso, articolato, multidisciplinare, sarebbe interessante poter affrontare insieme , con altri incontri, ogni possibile percorso. Dialogare attorno a questo mito che si perde nella notte dei tempi significa addentrarsi nei domini dell'astronomia, della mitologia, della religione, della storia, delle arti figurative, dell' artigianato: insomma significa tentare di codificare diversi sistemi di segni attraverso i quali l'uomo fin dall' origine ha tentato di rappresentare il mondo. E la Grande Madre, per un periodo lunghissimo e lontanissimo è stata l'unica spiegazione che l' uomo potesse darsi dell' esistente. Una spiegazione che oltrepassa i confini dello spazio e del tempo. La Grande Madre, infatti come dicevo poco sopra, non coincide con una fenomenologia definita: è piuttosto un sentimento, un archetipo che sta dietro a diverse rappresentazioni; è il sentimento dell'energia creatrice, generativa che l'uomo scopre in sé e nel mondo agli albori della propria coscienza e che gli fa pensare che esista un dio, o….. una dea. Nonostante le sue origini siano antichissime, le sue tracce hanno viaggiato nel tempo giungendo fino a noi: basta solo volerle scoprire; nonostante la presenza di questo mito sia stata attestata prevalentemente in precisi contesti culturali, indagando si scopre che la Grande Madre ha conosciuto una diffusione ecumenica, cioè universale, fino a costituire una invariante antropologica comune a tutte le civiltà umane. Proviamo ad iniziare la nostra indagine chiedendoci per il momento a quando risale questo mito. Come vedremo successivamente, tracce archeologiche riconducibili al mito della Grande Madre risalgono a 250.000 anni fa: una distanza temporale significativa. Per capire il significato autentico e originario di questo mito, dovremmo forse sforzarci di abbandonare gli schemi attraverso cui conosciamo e interpretiamo la realtà che ci circonda e porci di fronte agli eventi della vita con gli occhi di un uomo primordiale, privo degli strumenti cognitivi, intellettuale e scientifici che noi tutti oggi possediamo; dovremmo focalizzare la nostra attenzione sulle cose dell'esistenza che oggi ci sembrano banali, insignificanti. Spesso mi sono chiesta come potesse reagire un uomo primitivo di fronte ad eventi straordinari come la gravidanza e il parto, la nascita di un bimbo, ma anche di un animale, o ancora come si desse spiegazione del germinare delle piante da terra e o sui rami degli alberi. E proviamo a pensare quali sensazioni potesse suscitare nell' uomo primitivo l' accadere della morte. Noi oggi per lo meno possediamo dei nomi, con cui designamo questi eventi: nemmeno noi contemporanei sappiamo cosa siano la vita e la morte, ma avendo imprigionato questi misteri nelle maglie del linguaggio, ci illudiamo di poterli conoscere. Per l'uomo primitivo, ciò che noi oggi ci illudiamo di conoscere, rimaneva invece un insieme misterioso di odori, visioni, sapori, rumori di fonte al quale non poteva che provare un sentimento panico, un misto di timore e fascino. Di fronte a questi insondabili misteri i primitivi hanno provato il sentimento del sacro. La Grande Madre, in sostanza potrebbe coincidere con questo sentimento: in questo mito, così complesso, nei millenni di storia, l'umanità potrebbe aver condensato tutte quelle immagini ed emozioni in qualche modo connesse alle manifestazioni della vita e della morte; essa rappresenta l' Alfa e l' Omega, la sacralità inviolabile, potente da cui sgorga, inesorabile e misteriosa la forza generatrice della totalità della vita. Proviamo ad immaginare come l' evento di una gravidanza potesse essere vissuto dalle comunità dei nostri antenati: un corpo femminile, misteriosamente si trasforma, si modifica; nell' arco di nove mesi il ventre si gonfia, si gonfiano anche i seni e da questa metamorfosi scaturisce una nuova vita. Che cosa rimane impresso nella mente di un primitivo? Presumibilmente la doppia metamorfosi del corpo femminile che prima si gonfia per ritornare poi uguale e se stesso; presumibilmente il flusso d' acqua che precede il parto vero e proprio. Ecco, soffermiamoci su questi fenomeni, la generatività, la ciclicità della trasformazioni, perché saranno proprio questi a fornirci le chiavi di lettura delle rappresentazioni più significative attraverso cui si è data forma all'archetipo della Grande Madre. Non credo che la conoscenza, né il pensiero primitivo avessero stabilito nessi biologici e logici tra l' esperienza sessuale e la generazione di un nuovo essere vivente. Solo la scienza moderna, nel 1700, ha ipotizzato e dimostrato l'esistenza di questi nessi. Il pensiero primitivo dimostra di essere diverso dal nostro, cioè da quello dominante nella cultura occidentale. Noi pensiamo utilizzando categoria logiche: c'è un prima e un dopo, un sopra e un sotto; c'è l'identico e il diverso, c'è la forma e c'è la sostanza, una causa e un effetto. Il pensiero primitivo sembra essere invece soprattutto analogico e più che interpretare per distinzioni in categorie, sembra procedere cogliendo le somiglianze. Seguendo il percorso di questo pensiero, se una nuova vita appare in seguito ad una metamorfosi, il mistero della vita, la Grande Madre sarà quella metamorfosi. Metamorfosi e partenogenesi, cioè riproduzione asessuata, possono costituire alcuni indicatori dietro i quali riconoscere il mito della Grande Madre. Guardiamo un esempio di statuetta steatopagica , FIG. 1 , in questo caso la VENERE DI WILLENDORF. Siamo di fronte ad un'opera scultorea realizzata 20.000 anni fa e rinvenuta in un contesto prossimo alla nostre aree, cioè in Austria. La tipologia morfologica è tuttavia diffusa in tutto il bacino del mediterraneo: testimonianze analoghe provengono dal contesto cicladico e l' inverno scorso, esemplari simili si sono rinvenuti sul fondo del lago di Bracciano, vicino a Roma e ancora più vicino a noi, sull' Altopiano di Asiago. Nonostante la statuetta sia stata catalogata sotto la denominazione di VENERE, vedendola non possiamo non pensare alla metamorfosi del corpo femminile attraversato dal mistero della vita: ventre e seni rigonfi ne sono i segni inconfondibili e dietro a questa piccola VENERE - cm 11,5 - c'è sicuramente la Grande Madre. Queste statuette erano oggetto di culto, erano oggetti sacri che presiedevano ai riti di fertilità; chi ha eseguito questo lavoro non voleva evidenziare una individualità – e infatti la statuetta è spersonalizzata da un volto indistinto -, ma una entità universale: nella forma di una donna segnata dalla gravidanza un uomo di 20.000 anni fa ha voluto rappresentare la forza generatrice del mondo. Tuffarsi in un passato di 20.000 anni, significa entrare nel paleolitico: l'uomo ancora caccia , si nutre di bacche e frutti selvatici, trova riparo casuale in grotte naturali ; ha elaborato una conoscenza tecnologica che gli consente di costruirsi gli utensili necessari alla caccia , gli stessi che probabilmente usa per scolpire la pietra e incidere le pareti delle caverne in cui alberga. Tuttavia, come ipotizza Giuseppe Sermonti , il processo che porta, lungo un cammino millenario, alla definizione morfologica delle statuette steatopagiche inizia ben 250.000 anni fa. Al periodo Acheulano risalgono ciottoli scheggiati FIG. 2 caratterizzati da una particolare curvatura, interpretabile come una curvatura lombare che designa l' ansa dei glutei. Ritroviamo il principio partenogenetico in altri contesti, lontani nel tempo e nello spazio da quello prima preso in esame. Esiodo, autore greco del VIII° sc. A. C. nella sua cosmogonia, opera letteraria che racconta gli inizi del cosmo, afferma che all' inizio di tutto era Gaia, Gea la terra: dalla sua forza creatrice, in modo asessuato Gaia genera Urano, il cielo stellato così da potersi fare abbracciare da lui e non essere più sola. Anche Yeba Belo o Ava, Grande Madre dei Desana del Vaupes brasiliano è all' origine di tutto: si autogenera con la forza del proprio pensiero. Successivamente, nutrendo la sua anima con fumo di sigaro e caca, genera i Cinque Tuoni, cui delega il compito di creare il mondo e gli uomini. Ava è sicuramente la più trasgressiva delle Grandi Madri; forse la più metafisica perché la sua forza generativa risiede nel suo pensiero. L'aggettivo di trasgressiva, riferito all' assunzione di coca, è una battuta. L' assunzione di erbe stupefacenti è invece intimamente collegata ai sistemi culturali e ambientali di ogni civiltà, soprattutto, a quelle caratterizzate da forme di religiosità sciamaniche, caratterizzate da momenti rituali in cui grazie appunto all' assunzione di sostanze stupefacenti, si entra in uno stato di trance che libera dalla coscienza, ovvero di ciò che individuando l'uomo, lo distingue dal mondo, per ritrovare l'originaria fusione con esso. La metamorfosi come principio generativo, ritorna nel bacino del mediterraneo, in età neolitica, circa 10.000 anni fa.. Nel sito turco di Catal Huyuk, composto da unità abitative e templi, le superfici di questi ultimi sono decorate da affascinanti cicli di affreschi. Uno di questi è stato catalogato coma "" La nascita della Grande Madre "" FIG. 3. L'affresco, come indica Giuseppe Sermonti2 va letto in senso orizzontale, iniziando dalla bande laterali e procedendo fino a quella centrale. Iniziamo da qui, per riconoscere una morfologia già nota: una figura femminile steatopagica, assisa: una Grande Madre quindi. Alla definizione di questa sagoma si giunge progressivamente attraverso passaggi metamorfici che partono dai lati, dove è possibile riconoscere una sequenza di forme che richiamano chiaramente i genitali maschili: il mito è chiaro: la Grande Madre di Catal Huyuk è generata dalla metamorfosi dei genitali maschili. Non si po' non notare la strettissima analogia con la cosmogonia di Esiodo, composta quasi 9.000 anno dopo questo affresco anatolico. Esiodo racconta che Gea, disperata per il comportamento di Urano assassino di quasi tutti i loro figli, organizzò con Krono, uno dei pochi suoi figli sopravvissuti, di evirare Urano. Così accadde; i genitali del dio furono gettati nel mare e dal loro contatto con la schiuma marina si generò Afrodite Urania. Ma anche osservando contesti culturali a noi più vicini, la cultura cristiana, scopriamo la permanenza di miti partenogenetici: Gesù è frutto di una immacolata concezione e anche S. Anna, a quanto ci dicono alcuni vangeli apocrifi, concepisce Maria in modo misterioso, visto che Gioacchino rimane nel deserto, lontano dalla moglie per una lungo periodo. Quindi metamorfosi e partenogenesi principi generativi attribuiti alla Grande Madre. A partire dall'età neolitica si configura un altro attributo al mito: l'identificazione con l'acqua, tutte le manifestazioni che la possono ricordare, e soprattutto la terra. Non è casuale che questo avvenga appunto in età neolitica, periodo collocato indicativamente intorno ai 10.000 anni fa, e durante il quale l'umanità consolida definitivamente l'uso agricolo della terra. A questa pratica l' uomo deve essere giunto gradualmente, forse in modo casuale, sperimentando, applicando e sviluppando le tecniche agricole. L'uso agricolo della terra rappresenta una rivoluzione economica e sociale: i gruppi umani devono essere vincolati al suolo che coltivano; iniziano quindi a stanziarsi e a raggrupparsi in piccole comunità, in villaggi; l'umanità scopre progressivamente i vantaggi dello stare sociale, delle regole della vita comunitaria. E' soprattutto in corrispondenza di significativi corsi d'acqua, che si insediano queste prime comunità agricole, grazie alla fertilità del suolo irrigato e fertilizzato dalle naturali dinamiche dei fiumi. E' presumibile che fin dal Paleolitico sia stata la donna a tramandare le conoscenze relative alle piante: l' inferiore forza fisica rispetto ai maschi la rendeva meno adeguata ad occuparsi di caccia. Quando ancora non si viveva di agricoltura, ma di raccolta, la capacità di distinguere piante commestibili da quelle velenose, la conoscenza delle dosi opportune in cui mescolare foglie, radici e bacche era essenziale alla sopravvivenza: sbagliare una pianta o un dosaggio poteva essere letale. E' probabile che questa ripartizione dei compiti tra uomini e donne si sia consolidata anche in epoche successiva, nonostante la crescente complessità sociale introducesse nuovi criteri di distribuzione dei ruoli. In seguito a questa tradizione proprio la figura femminile avrebbe accumulato e tramandato i segreti della farmacopea, essenziali alla pratiche di riti sciamanici e taumaturgici, cioè curativi. L' identificazione della Grande madre con l'acqua, e con tutto ciò che la richiami morfologicamente rimane in un culto a tutti noto: mi riferisco a Lourdes. Questo luogo è morfologicamente molto particolare: una caverna naturale con all' interno una sorgente d'acqua. L'archeologia ci ha testimoniato di molti rituali localizzati in prossimità di sorgenti o grotte; non è casuale che la pastorella di Fatima abbia visto proprio qui la Santa Vergine: il luogo doveva essere sacro da una tradizione millenaria e la densità di siti paleolitici nella regione di Luordes, in generale in tutta la Spagna settentrionale – grotte di Altamira – e nelle Francia meridionale - grotte di Lescaux – rende credibile questa ipotesi. L' identificazione della Grande madre con l'acqua, è alla base della suggestiva ipotesi formulata da Giuseppe Sermonti relativa l' origine della Via Lattea, o meglio, della codificazione di quell'insieme splendente di stelle che attraversa sinuoso come un fiume lo spazio del firmamento. Nelle notti primitive, non ancora intaccate dall' inquinamento luminoso , quell' ammasso fluente , bianco che attraversava il cielo poteva ricordare ai nostri antenati il flusso dell'acqua che precede il parto; quello del fiume da cui si originano i fertili depositi di limo. Sermonti fa notare che sul piano dell' eclittica la via lattea si incontra con la costellazione dei Gemini, due stelle simili per splendore e grandezza. Questa struttura – un flusso centrale al cui inizio si stagliano, quasi a fare da guardiane , due figure gemelle, potrebbe costituire un archetipo attraverso cui da millenni – secondo i calcoli astronomici proposti da Sermonti almeno da 22.000 anni – l' umanità rappresenta la Grande Madre, il principio generativo delle cose. Ritorna, ad esempio, la medesima struttura, in una statuetta in terracotta proveniente dal sito di Catal Huyuk FIG. 4 : la figura centrale, questa donna dal corpo greve, appesantito dalla vita che lo attraversa, è assisa in trono: è un Grande Madre – commovente che una figura tozza, i seni penduli, il ventre gonfio, la corporatura massiccia, sia sacralizzata al di là di ogni canone estetico: la sua bellezza è nel mistero impetuoso che la plasma - ; ai lati del trono, simmetrici rispetto alla figura centrale due protomi, di agnelli forse, o qualcos'altro. Non è questo ad interessarci, ma la struttura: una Grande Madre centrale e due figure gemine laterali, esattamente analoga alla via lattea in intersezione con Gemini. Spostiamoci ora in un altro contesto culturale, Micene, 1800 anni a.C. e soffermiamoci su una delle porte cittadine FIG. 5 : sull' architrave due leoni gemini e simmetrici posti a guardia dell'accesso alla comunità. Dall' età neolitica, a cui risalgono i primi insediamenti stanziali, il villaggio acquista valenze multiple: è la sede dell'identità del gruppo, è il luogo dell'appartenenza, è il rifugio dove sono conservate le scorte alimentari; ad esso si contrappone tutto quanto ne esula, l' esterno incolto, pericoloso, sconosciuto, desertico. La Grande Madre è l' entità fondatrice e protettrice del villaggio, per rappresentarla gli Achei di Micene hanno attinto ad un archetipo tramandato da millenni. E la ricorrenza di questa struttura, derivata da una primordiale codifica della fenomenologia astrale, imperniata sulla identificazione Grande Madre – Acqua, si ritrova millenni dopo nella mitologia greca; Cibele, la Grande Madre frigia ha al suo servizio la coppia dei Dioscuri Castore e Polluce: ancora una Grande Madre accompagnata da una coppia gemina. Si diceva che a partire dall'età neolitica il principio generativo inizia ad essere associato alla terra oltre che all' acqua. Troviamo la Grande Madre in sembianze di creature ctonie, sotterranee, cioè legate alla terra - serpi, draghi - in due opere di contesto babilonese, le prime opere scritte dell' umanità. L' Epopea di Gilgamesch e L'Epopea della creazione risalgono all'inizio del 2° millennio a.C. e sono state incise su tavolette di argilla in caratteri cuneiformi. Nell' Epopea della Creazione, all'origine di tutto c'è Tiamat, dragonessa cui spetta il compito di creare il mondo. Nell' Epopea di Gilgamesch il riferimento alla Grande Madre è indiretto. L'epopea racconta le gesta di Gilgamesch, creatura semidivina, eroe di una civiltà ormai evoluta, ormai lontana dalla natura originaria. Nel confronto con Enki suo alterego, Gilgamesch tradisce la nostalgia della sua civiltà per le lontane origini perdute. Nel corso del racconto Enki muore; Gilgamesch, disperato per il lutto, affronta una serie di peripezie alla ricerca della pianta della vita eterna; la trova, immersa nell'acqua di un fiume; è sua, ma improvvisamente dal letto del fiume una serpe emerge e gliela ruba per sempre. Solo alla serpe, ctonia sembianza della Grande Madre, può spettare il segreto dell'immortalità. Nella mitologia greca le figure ctonie femminili sono numerose: Pitone, primo oracolo di Delfi, è una serpe cui il mito attribuisce i misteri della saggezza e i poteri divinatori; Latone è una serpentessa avvinghiata ad un albero nel giardino di Occidente: ella presiede alle Esperidi, ninfe crepuscolari, guardiane del giardino e soprattutto delle mele d'oro che fruttificano dai suoi alberi. E' immediato un riferimento all'Eden biblico, al serpente avvitato all' albero sacro della conoscenza. Questa morfologia travalica i confini del tempo e dello spazio; una fiaba medievale, di derivazione latina, Melusina, racconta di una principessa FIG. 6. È molto bella, saggia, prolifica; fa dissodare la terra, ma ha un segreto: ogni sabato deve scomparire per immergersi in uno specchio d'acqua dove si trasforma in una creatura per metà donna e per metà drago. Anche nella nostra tradizione orale esistono figure analoghe, le anguane, per esempio. Sono donne semidivine che incantano con la loro bellezza i comuni mortali, si danno al loro amore a patto che rispettino il loro segreto: anche le anguane, una volta alla settimana devono sparire per immergersi in uno specchio d'acqua, dove, tramutandosi in serpi, si rigenerano. Un siffatto specchio d'acqua, magico e sacro è attestato anche dalle nostre tradizioni locali, che lo identificano con il Subiolo, a Valstagna. L'identificazione del principio generativo con la terra è esplicita nella cosmogonia di Esiodo, dove , come abbiamo già visto, il principio originario e creatore è Gea, Gaia, cioè la terra. Anche gli alberi costituiscono un richiamo alla terra: essi vi affondano le radici traendone nutrimento per produrre fiori e frutti. Nelle mitologie nordiche la sacralizzazione dell'albero o del bosco è ricorrente: molte figure magiche, come le fate, soprattutto della tradizione gallica, sono signore e protettrici dei boschi. In uno dei miti greci dedicati ad Atena, le dea è compete con Poseidone per il controllo su Atene. E' la divinità femminile a vincere, donando alla città l'albero dell'ulivo, divenuto sacro. Dietro all' Eretteio, nell' Acropoli di Atene, un recinto sacro circonda l'antico luogo dove sarebbe comparso il primo ulivo. Un residuo della identificazione Grande Madre – albero è forse rintracciabile nella tradizione, consolidata anche nel nostro territorio, delle madonne arboree. Epifanie, cioè comparse, della Vergine Maria sulle chiome di un albero o nelle sue adiacenze sono testimoniate nelle tradizioni locali di tutta la penisola; all' albero così beatificato, si appendono ex voto o si accostano cappelle votive, i nostri capitelli. Anche nel nostro territorio non è raro trovare un capitello affiancato ad un albero, soprattutto carpini. Un' altra peculiarità dei capitelli ci riconduce alla Grande Madre: essi sono localizzati sempre in corrispondenza di bivi o trivi, insomma in corrispondenza di un crocevia. Questo luogo deve aver assunto per le culture arcaiche pregnanti significati esoterici e religiosi. I crocicchi erano presieduti nella mitologia greca da divinità complesse e misteriose, come Hermes o Ecate, il cui culto nel nostro territorio è attestato fin dall'epoca preromana, Ecate, arcana, potente, diurna e notturna e le sue orchesse, tra cui Empusa sono un residuo della Grande Madre primitiva; esse possono arrecare all' uomo benefici o malefici. Da qui l' esigenza di doni votivi per ingraziarsi i poteri soprannaturali. Anche in culture estranee a quella occidentale, per esempio africane, i crocevia assumono il medesimo significato e hanno prodotto nei secoli analoghe manifestazioni votive. Ulteriore attributo della Dea Madre è il ritorno, l'inesorabile ritorno ciclico. Cicliche sono le fasi lunari; cicliche sono le maree; ciclico è il sorgere e il tramontare del sole, cicliche ancora, sono le stagioni, ciclica è la vita che si frange nella morte per poi rinascerne. Non è casuale che per esempio la Madonna arborea di Bagni, in Umbria, si presenti con un'iconografia che la associa al falcetto lunare. Ma il mito più eloquente è forse quello greco di Demetra. Demetra è una delle divinità olimpiche, figlia di Rea e Krono. È madre di piante e animali e spesso si manifesta in sembianze di spiga o giumenta: è quindi legata alla terra e ai suoi cicli. Demetra ha una giovane figlia, Persefone che un giorno le viene rapita da Ade, dio degli inferi. Demetra inizia la ricerca affannosa della figlia; per il dolore e la rabbia, rende sterile la terra. La situazione si protrae al punto che gli esseri umani non hanno più alcun bene da offrire agli dei. Interviene allora Zeus, che consentirà a Persefone di riemergere dagli inferi, ai quali dovrà però tornare per un terzo dell' anno. Durante questo periodo Demetra, rimpiangerà la figlia impedendo alla natura ogni germoglio. Dietro a questo mito, si ravvisa il ciclico divenire stagionale, che alterna a periodi di fecondità, come la primavera, l' estate, l'autunno, periodi in cui la terra sembra assopirsi e quasi morire. Nel mito di Trittolemo, Demetra è la divinità che dona agli uomini i cereali, e per questo le saranno tributati i culti eleusini. Ma nella narrazione Demetra compie un gesto che la collega , come un filo diretto, a Taniquilla, figura della mitologia latina e poi a Melusina, che abbiamo già incontrato come protagonista di una fiaba francese medievale. Tutte e tre hanno a che fare con un neonato maschio: Demetra con Trittolemo, Taniquilla con Servio, figlio di una sua ancella e futuro re di Roma, e Melusina con gli ultimi suoi due figli. Tutte e tre, di notte accudendo il neonato lo avvicinano al fuoco; Demetra e Melusina lo allattano anche. Come interpretare questo gesto ricorrente in contesti culturali così lontani? Possiamo pensare che i racconti alludano o conservino la memoria di lontani rituali che vedevano coinvolti i neonati? I resti neolitici provenienti da un sito italiano, la grotta dei Piccioni in Basilicata, sembrano confermare questa ipotesi e venarla di colori cupi; essi attesterebbero riti legati alla fertilità, alla semina durante i quali per propiziarsi il favore delle energie sovrannaturali si sacrificavano neonati e bambini. Fin qui si è cercato di evidenziare le ricorrenza di invariante antropologica di questo mito, come si è visto , antichissimo. Un ricorrenza oltre i confini del tempo e dello spazio; una continuità su cui poter riflettere. Questo mito sembra costituire un archetipo della mente umana, una forma del pensiero, antica che per millenni ha sostenuto l'uomo nella interpretazione di sé e del mondo. E se essa potesse ancor oggi costituire per l'essere umano una alternativa, una visione su se stesso e sulle cose, complementare a quella sviluppatasi nell'epoca contemporanea? 2. La materia: il luogo della Grande Madre. Il titolo di questo incontro, LA MATERIA: LUOGO DELLA GRANDE MADRE , risulta riduttivo oggi rispetto al contenuto , che dallo scorso autunno ho modificato sulla scorta di due avvenimenti. Il primo è il conferimento del premio nobel per la pace dello scorso anno, alla signora keniota. K. Mootai. Questa donna si è vista insignita del prestigioso riconoscimento internazionale sostanzialmente per aver piantumato, nel corso di dieci anni, trenta milioni di alberi sui clivi del Monte Kenia, coinvolgendo in questa iniziativa gruppi di donne, togliendole da un destino di emarginazione sociale e sfruttamento. In una intervista rilasciata al corriere della sera il 9 ottobre, la Mootai lascia intravedere nelle motivazioni etiche e religiose sottese alla sua iniziativa, un richiamo ad un sapere, ad una religione antica; la sue parole sono "" una volta la gente credeva che gli dei abitassero il Monte Kenia e lo veneravano; adesso si dicono cristiani, vogliono andare il paradiso e distruggono la fonte della loro vita "". Il secondo avvenimento è la tragedia provocata dallo Tzunami, in particolar modo l'esito di questo che questo fenomeno naturale ha avuto sulla popolazione andamana: i pochi abitanti di queste isole, colpite in pieno dall'onda, sono sopravvissuti in percentuali altissime; caratteristica di questa popolazione, formalmente sotto giurisdizione indiana, è di aver rifiutato anche violentemente qualunque forma di contatto e assimilazione ai modelli oggi definiti globali. Li ha salvati un sapere antico: hanno riconosciuto immediatamente il pericolo nella profonda risacca del mare; hanno saputo dove rifugiarsi; le loro abitazione sono sempre state edificate oltre una certa linea dalla costa e in materiali leggeri – il legno -. Alla luce di questi due avvenimenti, accomunati dal recupero ovvero preservazione delle tradizioni arcaiche, quindi, come cercheremo di vedere, del mito della Dea Madre, viene da chiedersi se un ritorno alla nostra mente antica non possa rappresentare per l'uomo contemporaneo, una auspicabile prossima frontiera. Il percorso di questa lettura sarà quindi il seguente: a) cercheremo di chiarire cosa si intenda per Grande Madre da una prospettiva iconografica e storica; b) vedremo, con l'ausilio della ricerca svolta da Tiziana, come elaborato di tesi di laurea, che quanto definiamo Grande Madre, almeno nelle sue manifestazioni iconografiche, è rimasto nel tempo, celata forse nelle profondità della nostra mente , fino ai giorni nostri c) vorremmo cercare di indagare il significato originario di quelle traccia del passato che le scienze umane contemporanee hanno classificato con la denominazione di Grande madre – Dea Madre; d) Cercheremmo di individuare alcuni possibili fattori che nella storia della civiltà occidentale, hanno contribuito a spezzare la continuità storica di questa forma mentale; 2. a ) La Grande Madre in una prospettiva storico-iconografica In questa prospettiva definiamo prime tracce storico-iconografiche della Grande Madre, gli oggetti di culto configuratisi nella morfologia delle Veneri steatopagiche di cui abbiamo già visto un esempio nel primo paragrafo. Riprendiamo brevemente questo argomento: le testimonianze più antiche di questa tipologia di manufatto risalgono a 30.000 anni fa, al paleolitico, almeno per l'ambito europeo- mediterraneo, in cui questa tipologia di oggetto ricorre senza differenziazioni significative dalle aree occidentali – Spagna – a quelle orientali – Malta, a quelle più settentrionali – Austria, Lazio ed è allo studio in questo periodo un reperto proveniente dall'Altopiano di Asiago -. Il significato storico di questi manufatti è indiscutibile, poiché essi documentano una identità culturale distribuita su un a territorio molto ampio, dal mediterraneo al continente europeo centrale ed occidentale, nello stesso arco temporale – il paleolitico -, identità verificabile sulla scorta dell'analogia morfologica e tecnico-linguistica di questi oggetti. Analogamente alle scritture più antiche – il cuneiforme mesopotamico – così queste morfologie hanno fornito all'evoluzione dei linguaggi visivi, criteri e strutture compositive, e i relativi rinvii semantici. Il tema/la poetica della Grande Madre si ravvisa lungo un asse diacronico temporale e sincronico spaziale, quasi senza soluzione di continuità; linguaggi visivi lontani millenni, dall'arte del paleolitico, ne hanno sorprendentemente conservato i criteri compositivi. Anche le immagini di miti e leggende, modi di trasmissione culturale potremmo dire fossili, confluiscono nella ricerca dell'arte contemporanea. L'installazione dell' Artista Yufen, del 1994, Primavera di giada, con i suoi panni stesi in un cortile attorniato da sculture femminili classiche, sembra riprendere un soggetto legato alle leggende dei nostri luoghi sulle Anguane, queste misteriose deità femminile, molto complesse, legate alla simbologia rigenerativa dell' acqua. In molte leggende infatti, quelle legate alla grotta il Buso della rana a Priabona, al subiolo di Valstagna, al castello di Marostica queste deità compiono un gesto che probabilmente è rituale: stendono i panni. Lo stesso gesto è di Nausica, la principessa di Scheria che accoglie Ulisse dopo l'ennesimo naufragio. 2. b ) La grande Madre: archetipo del sentimento del sacro Torniamo ai manufatti paleolitici. L'indagine comparata dei dati storici e antropologici conduce al risultato condiviso che si tratti di oggetti rituali, oggetti di culto: non si ravvisa infatti nella loro struttura nessuna finalità funzionale-operativa; sono oggetti comunicativi, rappresentano qualche cosa. Ma che cosa rappresentano? Molti studi relativi a questo soggetto hanno fornito la denominazione Grande Madre – Dea Madre per rispondere a questo interrogativo, ma si tratta di una concettualizzazione postuma ovviamente rispetto alla originaria attribuzione di senso. Ma possiamo affermare con certezza che l'artefice di questo oggetti, che ricordiamolo risalgono anche a 30.000 anni fa, volesse significare esattamente ciò che noi oggi intendiamo con il concetto MADRE, o con il concetto DEA? I dubbi sulla correttezza, o meglio sulla effettiva corrispondenza di questa definizione al significato originario di questi manufatti è legittimato da alcune considerazioni di vario ordine, in particolare di ordine storico, antropologico e linguistico. La considerazione di ordine storico è la seguente: come abbiamo già avuto modo di vedere precedentemente, dobbiamo anticipare di quasi 200.000 anni la produzione di manufatti presumibilmente connessi ai tratti morfologici e semantici delle statuette paleolitiche viste prima. G. Sermonti infatti ravvisa già nelle cosiddette AMIGDALE , risalenti all'Acheulano, 250.000, quella morfologia a profonde rientranze e pronunciate sporgenze che raggiunge la sua perfezione plastica appunto nelle statue paleolitiche. Abbiamo a che fare quindi con un Sapiens Sapiens veramente molto lontano da noi Per quianto riguarda la riflessione più specificatamente antropologica, si deve comunque partire dalle parole. Il sostantivo attuale di MADRE rinvia ad una stratificazione semantica molto complessa, in cui riferimenti psicologico-affettivi si sovrappongono a riferimenti di contenuto sociale. La parola madre indica un'entità certamente affettiva, che si distingue però anche come ruolo definito e riconosciuto socialmente. Ci dobbiamo chiede se questa parola e le sue connessioni semantiche esistano già 250.000 anni fa e ponendoci questo quesito dobbiamo interrogarci inevitabilmente sulla storia del tabù dell' incesto. Il tabù dell'incesto distingue l' organizzazione delle strutture sociali animali da quelle umane, ma possiamo affermare con certezza che l'autore delle amigdale e delle statuette di cui sopra fosse un uomo la cui mente avava già elaborato-interiorizzato questo tabù? Se così non fosse questi manufatti non possono rappresentare una MADRE, - perché ancora questo ruolo affettivo e sociale non esiste - , ma qualcos'altro. Cosa? Per cercare di capire possiamo comparare altri manufatti contemporanei alle "" grandi madri "" paleolitiche, anch'essi oggetti di culto. Esiste una correlazione tra questi manufatti e le cosiddette dee madri? Veniamo alla terza e ultima considerazione di natura linguistica . Esiste una continuità etimologica e semantica tra le parole latine MATER E MATERIA: Semerano spiega questa continuità con questa analisi : MATER: sanscrito MATA, antico slavo MATI , lettone MATE, sumero AMATU = GENERATRICE, GENERANTE; accadico WATRU – MATRU = prominente, sporgente, grosso, della stessa radice di MATARU-ATARU = ingrandire. Per le corrispondenze in accadico tra W/M/B e quindi tra ATRU, MATRU, WATRU, UTRU, si chiarisce che MATER, VENTER, UTERUS, derivano dalla stessa base, cosi anche il latino MATURUS = che ha avuto il suo sviluppo ( in seguito ad un cambiamento ) – MATERIA - AE = sostanza da cui qualcosa deriva, principio delle cose, ad esempio il tronco d'albero che produce rampolli ( in greco reso da ??? = parte ombrosa di una selva, sterpaglia per il fuoco, accadico SULULU = oscuro, sumero UL che richiama accadico ALAPU, ELEPU = germogliare. Che cosa si può non concludere, ma osservare alla luce di queste riflessioni? Possiamo ancora risolvere il mistero del loro senso, nella forma di un corpo femminile gravido? Questi antichi manufatti sono oggetti rituali, oggetti di culto; essi rappresentano qualcosa di sacro, forse anche oggetti sacrificali = ex voto. Che cosa è sacro per questo antichi uomini? Su che cosa si debba intendere per SACRO sono stati scritti fiumi di parole. Certamente i processi di sacralizzazione sono di natura culturale, quindi soggetti a variazioni sincroniche nell' asse dello spazio e diacroniche lungo l'asse del tempo, e soggetti anche a persistenze che producono invarianti. Tentare di capire oggi cosa potesse risultare sacro ad un uomo di 250.000 anni fa risulta difficile, ma forse non impossibile, visto che certe forme antichissime ritornano, come abbiamo visto per le arti visive, a distanze temporali veramente notevoli. Durante questa indagine è utile tenere presente che l'uomo di cui ci stiamo occupando si colloca al remoto esordio della cultura; ciò che la nostra tradizione culturale ci rende ovvio, per quest'uomo antico è ancora oggetto di curiosità, di quella "" brama di conoscenza oggettiva "" , di cui parla Levi Strass per descrivere l'attitudene del pensiero dei popoli cosiddetti allo stato di natura. Non ci sono ancora SIGNIFICATI, ma solo ESPERIENZE da attraversare, conoscere. Il sacro per quest'uomo, è una condizione pregressa a qualunque domanda sul mondo; la domanda è infatti un atto linguistico che presuppone la risposta, mentre il tempo in cui stiamo cercando di entrare, risposte ancora non ne ha. La nascita, la morte, la crescita, le variazioni metereologiche, le innumerevoli fenomenologie naturali: l'uomo di cui stiamo parlando non sa ancora che cosa sono, non sa perché avvengano, non ne conosce le conseguenze. Il suo pensiero funziona secondo dinamiche prevalentemente analogiche, non logiche: categorie come sopra-sotto; prima – dopo; diverso-uguale non organizzano ancota la sua conoscenza, che invece si costruisce soprattutto per somiglianze. Cosa accomuna morte, nascita, crescita, stagioni, giorno, notte, inverno freddo, estati calde, giornate torride e insopportabili siccità ? Il cambiamento; la materia tutta, si manifesti nella forma del corpo umano, di quelli animali e vegetali, nel succedersi dì-notte, e delle stagioni, condivide un unico medesimo processo, cioè la trasformazione, la metamorfosi da una forma in un'altra. Ciò non sfugge alla "" brama di conoscenza oggettiva "" di quest'uomo primordiale, ma contemporaneamente tutto quanto si svolge all'attenzione dei suoi sensi o attraversa il suo corpo, prescinde la sua volontà, non si spiega, non rivela la sua origine, né il suo fine. Questo inesorabile silenzio spaventa, lascia stupefatti, fa sentire impotenti. Forse il SACRO è proprio il sentimento di smarrimento, fascinazione, terrore, rabbia che la coscienza umana è destinata a provare sempre di fronte a ciò che la limita, ad una alterità ineffabile e incontrollabile. Possiamo pensare che per gli antichi, questa alterità sia la totalità della materia, ancora non logicamente conosciuta, e in particolar modo la sua natura metamorfica senza inizio e senza fine. L'osservazione della morfologia delle statuette ci presenta con insistente frequenza un processo, un processo di cambiamento attraverso la materia di un corpo, il corpo femminile, che più di quello maschile conosce il mutamento. Esso progressivamente muta, crescendo si trasforma, diventa altro da sé: seno e ventre si gonfiano, i piedi si allargano per sostenere il peso crescente, la schiena si incurva per il peso; smette il flusso sanguigno, iniziano le perdite lattee del seno: il corpo femminile, forse prime ancora di assumere il ruolo che oggi definiamo con il termine di MADRE è una sintesi massima di metamorfosi. Il ventre improvvisamente diventa una sorgente di acqua e poi dopo ore, giorni di dolore immotivato il ventre si trasforma in un nuovo essere umano. Il corpo femminile oltre ad essere una sintesi massima di metamorfosi è anche una metamorfosi generativa, ma per trasformarsi in quel nuovo essere, il ventre gonfio, quella forma ha dovuto sparire: la trasformazione vincola inesorabilmente la comparsa alla scomparsa. Anche oggi quella scomparsa è percepita e sofferta dalla madre, come un lutto una perdita che si configura nella diagnosi della depressione post partum. Prima ancora di ricevere il significato di madre, il corpo femminile rappresenta per gli antichi nella maniera più esauriente il divenire generativo da cui tutta la materia è attraversata sotto l'occhio curioso, attento, intelligente e spaventato dei nostri progenitori. Questa ipotesi può forse avvalorarsi prendendo in esame altri esempi di manufatti paleolitici, quali ad esempio il graffito definito "" SCIAMANO e la statuetta "" UOMO LEONE "" : non rappresentano anch'essi una metamorfosi, una trasformazione da una sostanza – umana – ad un'altra – animale- ? Il sentimento del sacro rappresenta la soglia che spartisce il mondo animale da quello umano. Esso è connesso con i procedimenti psichici della coscienza: l'uomo elabora il sentimento del sacro dal momento in cui, nuove sinapsi gli consentono di essere consapevole, attraverso l'esperienza personale e la sua analogia con le fenomenologie naturali, della vita e della morte. Questi eventi che prescindono l'uomo e la sua coscienza per attuarsi attraverso il suo corpo, inducono nell'uomo sentimenti e pulsioni potenti, riconducibili da una parte al piacere, al desiderio di vita, dall'altra all'orrore, il ribrezzo, la paura della morte; esse si risolvono in uno sommesso stupore di fronte all'insondabile e inesorabile a priori della materia che diventa il luogo del sacro. Nei più diversi contesti culturali, lontano nello spazio e nel tempo, le diverse rappresentazioni della Grande Madre, ci ciungano esse in forma di manufatto, di mito, di leggenda, di divinità condividono alcuni tratti salienti ad primo fra tutti la intima connessione con le dinamiche fondanti della materia, cioè l'andatura ciclica e cangiante, metamorfica; si pensi ai cicli mestruali, lunari, stagionali, solari, delle maree; ai cicli vitali della nascita, crescita, invecchiamento, morte, ai cicli biologici che dalla putrefazione di alcune molecole ne generano altre. E' presumibile quindi che la religiosità primitiva sia estremamente concreta, imperniandosi sostanzialmente sulla sacralizzazione della materia, delle sue fenomenologie, delle sue dinamiche. La conoscenza storica di periodi cosi' lontani è inevitabilmente lacunosa; le sue ricostruzioni possono essere solo ipotetiche e deduttive. Sappiamo, da studi antropologici e psicologici, che le strutture valoriali religiose, legate al sentimento del sacro, costituiscono nella psiche umana la struttura profonda e portante su cui si innestano sistemi più superficiali, quello etico e quello giuridico. Guardiamo ad esempio, quanto il tabù dell'incesto è stato determinante nella definizione dei ruoli sociali e dei relativi comportamenti etici. Da questo esempio si può quindi dedurre che il culto della materia abbia in epoche lontanissime determinato precisi codici comportamentali, individuali e collettivi, concretizzatesi in un rapporto devoto e rispettoso nei confronti della innumerevoli manifestazioni della materia. Le popolazioni nomadi di stirpe germanica, prima di essere latinizzate e in seguito cristianizzate, avevano individuato nell'albero la forma del sacro; l'albero era per loro un totem, un tabù. L'abbattimento di alberi era regolato da precise norme e rituali, la cui violazione prevedeva pene cruente e orribili. L'uso dell'acqua, di albero di ulivo, del fuoco; l'uccisione di animali è sempre stata regolata nelle culture antiche da rigidi sistemi normativi e rituali. Possiamo dire, che queste pratiche abbiano garantito alle generazioni passate, ciò che la civiltà contemporanea affannatamene cerca di ripristinare cioè uno "" SVILUPPO SOSTENIBILE "" 3. Soluzioni di continuità dell'antico archetipo: la civiltà produce nuove forme di sacro La civiltà occidentale da tempo ha perso questa modalità religiosa, questo particolare sentimento del sacro, di cui ultima testimone è stata, per molti studiosi, la cultura greca. Che cosa è successo? Quli possono essere stati i fattori che hanno allontanato l'uomo occidentale dalla MATERIA SACRA. Poichè la partita si gioca nell'ambito del sacro, è forse lì che si deve indagare e si scopre che il pensiero occidentale si caratterizza per l'elaborazione di una peculiare forma di religione: la religione rivelata. Le religioni rivelate o abramitiche, riconducibili tutte e tre alla parola di Abramo hanno consegnato all'umanità una parola, non una esperienza, nemmeno un interrogativo, bensì una risposta: DIO. Questa parola è molto particolarem, perché in molte lingue antiche, manca di un referente ed è solo una tautologia di se stessa. – DEUS lat. ; T??? gr. DI'U acc = cripta, stele in una cripta che si sovrappone, escludendolo a DIR-DIMIR, DIMER sumero = dio DEVAH, sanscr. = celeste – Dio è solo un concetto, autoreferenziale, virtuale, che per le sue caratteristiche di astrattezza, di metafisicità, di eternità, in finitezza ecc…consente alla mente umana di sottrarsi all' impotenza di fronte alla incomprensibilità, al mistero, alla assoluta prescindibilità della materia rispetto alla volontà e alla coscienza umana; consente alla menta umana un solipsismo che la risparmia dalla morte e la proietta oltre il fisico, nell'eterna immortalità della metafisica. Con le religioni rivelate, probabilmente l'orrore insostenibile della morte e l'inaccettabile impotenza di fronte alla vita, la coscienza dell' individualità e dei suoi limiti inisorabili, inducono l'omo ad elaborare una cultura che spezza la continuità tra l'uomo e il mondo, basata sulla materia, il corpo, e elabora una continuità tra l'uomo e Dio. Il sacro a questo punto è estirpato dalla materia, dalla natura – phisis - e collocato in una dimensione meta-fisica, sovrannaturale. Dio e materia sono per la prima volta scissi; compare in queste religioni una figura nuova, quella del DIAVOLO, ovvero DIA BELLEI, gr. separare, il reietto, il separato da dio, il sovrano della materia contrapposto all' imperatore celeste. Non è casuale che a questa nuova figura si attribuiscano nel corso dei secoli tutte quelle immagini che, nelle antiche religioni, evocavano la materia creatrice: le metamorfosi – il diavolo ha sempre attributi animali o assume sembianze diverse – ad esempio; la collocazione sotterranea, come le primigenie deità ctonie.Contro l'ingannevole e duplice fenomenologia della Grande Madre, oramai demonizzata la quale, nel suo ciclico divenire nasconde, dietro il miracolo della vita, il baratro della morte, il nuovo dio è garante di un cammino lineare ed escatologico che conduce all'eternità. La sostanza della vita si modifica: essa non è più un alfa e un omega, individuati dalla nascita e dalla morte di un corpo, ma la salvezza eterna dell'anima. La capacità di inventare –creare qualche cosa dal nulla, ovvero la capacità di fantasticare, di astrarre, di creare parole è indubbiamente la facoltà che distingue l'uomo dagli altri essere viventi e d è la sua caratteristica più grandiosa ed esaltante, ma può degenerare in una fantasmagoria totalmente scissa, dissociata dalla realtà, in cui l'uomo si illude, si illude soltanto di vivere. La civiltà sostiene queste convinzioni da circa cinque mila anni; esse non hanno risolto alla radice il problema, ovvero la inesorabile contingenza della fine, ma hanno sicuramente radicato una forma mentis che finalmente ha esorcizzato l'orrido della morte, collocandolo lontano dalla verità. La morte non fa più paura, non è più sacra, con essa si può giocare quotidianamente, non turba più alcuna coscienza, rassicurata da millenarie promesse di eternità. L'allontanamento della morte l'illusione che esse non esiste perché la verità della vita risiede nell'anima, ha paradossalmente prodotto un'attitudine mortifera nei sistemi etici più recenti dell' occidente e dell'Islam. Nonostante le conquiste del progresso – tecniche, civili, scientifiche – la nostra civiltà non è meno mortifera di quanto lo fossero le civiltà precedenti, anzi, considerando morte anche quella di esseri viventi non umani, forse le civiltà abramitiche sono di gran lunga più mortifere di quelle che hanno precedute. Il processo di industrializzazione-mercantilizzazione dei sistemi economici, avviatosi quattro secoli fa in Europa, costituisce un ulteriore percorso di allontanamento dell'uomo dalla natura, materia. Nelle economie naturali il rapporto con le risorse è diretto, immediato; in questo sistema il soddisfacimento dei bisogni è intrinsecabilmente legato alla tutela delle risorse: nella storia economica europea preindustriale, i periodi di ripresa della produttività, secondo rilevatori quantitativi e qualitativi, con ricadute positive sulla demografia e sugli indici igienici, sono spesso collegati con una particolare tecnica agronoma che lascia una porzione del terreno a maggese, cioè a riposo; il terreno, non sollecitato da alcuna coltivazione per almeno un anno, rigenera le proprie sostanze minerali e chimiche, necessarie a sostenere le coltivazioni successive. Nelle economie industriali-mercantili il rapporto con le risorse è mediato da una serie di passaggi successivi; le risorse, che comunque rimangono alla base dei processi di produzione-distribuzione, diventano evanescenti; la necessità di preservarle, un optional. I processi produttivi hanno raggiunto fin dal secolo scorso, livelli altissimi di complessità; diventano ingovernabili alla coscienza individuale. Auswitz morfologicamente è uno stabilimento produttivo, per questo fino al 1945 il Reich nazista è riuscito forse a dissimularne la vera funzione; ad Auswitz erano impiegati con funzioni amministrative anche civili; quando furono messi di fronte all'orrore, dichiararono di aver svolto semplicemente il loro lavoro e di non aver saputo niente. Posso credere a questa dichiarazione : quanti lavoratori del metallurgico sanno che i componenti prodotti nel loro stabilimento saranno montati in oggetti letali; o più banalmente, quanti di noi sanno concretamente di che cosa è fatto il cibo che si compra al supermercato? Quante delle vittime dello Tzunami hanno mai riflettuto sul fatto che quel paradiso proprio perché artificiale, estraneo a quella natura e a quella cultura, avrebbe potuto diventare la loro tomba? Questa moderna Weltanschaung, si caratterizza per un tratto strutturale, ovvero la scissione delle cose: il consumo e i bisogni sono separati dalle risorse; il profitto è altro rispetto alla condizioni che lo generano; la sua etica è separata e indipendente dall' etica sociale, dall' etica umanistica. Solo una forma mentale teleologica, organizzata su un sistema valoriale escatologico, ovvero una mente formata sui criteri inaugurati dalle religioni metafisiche, può concepire questa visione del mondo. Non è un caso che proprio il manicheismo originario, fondato nel 3° sc. dopo Cristo in ambito iranico da Mani e rinvigorito nella cultura europea e cristiana dalla esperienza catara, avesse elaborato come precetto fondamentale l'astensione da ogni attività che richiedesse il contatto con la terra, con la meteria, ovvero in una prospettiva economice, dall'agricoltura. Agli adepti che aspiravano alla verità e alla purezza l'unica attività economica consentita era il commercio: attività che veicola, ma non manipola la materia. Dalla riforma protestante, secondo M. Weber, il capitalismo ha trovato una legittimazione nell'etica calvinista; il profitto,l'obiettivo verso cui è orientato il sistema, disloca nella linea del futuro la soddisfazione dei propri bisogni: il domani è ciò su cui si investe il benessere, non la contingenza, il presente, il qui e ora, che spesso vengono ignorati. La recente riflessioni filosofica mette in evidenza i limiti della civiltà contemporanea, ad esempio la assoluta mancanza di responsabilità nei confronti della vita non umana – animale, vegetale, minerale - ; oppure, per quanto riguarda l'etica più specificatamente cristiana, la legittimazione del dolore, come garanzia di un premio successivo; si tratta di limiti concreti che potrebbero risolversi in scenari futuri insostenibili per l'uomo, per la sua vita e per la sua coscienza. Non è possibile certo rinnegare una identità che si è definita in secoli di produzione e trasmissione culturale; è possibile però riflettere su questa identità, metterla magari in discussione, laddove presenti lacune e limiti; è infine possibile integrarla con confronti e dialogo con altre possibilità. La cultura antica, primordiale di cui la Grande Madre si può assumere come archetipo emblematico, può costituire per noi contemporanei una identità alternativa, per altro mai definitivamente scomparsa dalla nostra mente, con cui confrontarci. Cosa ci insegna questa cultura? Essa in prima istanza propone una percezione dell'uomo, non come entità scissa, bensì contigua con il resto del mondo, per cui la tutela della cose non può che tradursi come tutela della vita umana. Essa ci insegna ancora ad accettare e a convivere con la morte, con il dolore, la sofferenza intese non già come come frustrazione di aspettative insoddisfatte, ma come momento fondante della ciclica metamorfosi della vita. L'orrore della morte non si traduce con l'illusione di una vita eterna, ma con il rispetto della vita.
1. Ricorrenza di questo mito La ragione di questa indagine è innanzitutto personale: ho tentato di esplorare la fitta e contorta trama in cui si compone questo argomento esoprattutto ho colto in esso il veicolo di valori universali, vitali, che oggi sembrano inaridirsi nella quotidianità della vita contemporanea: mi riferisco al sentimento sacro e rispettoso di fronte alla via, di fronte alla natura, di fronte alla morte. Che cos'è la Grande Madre? Difficile definire un concetto, un sentimento, che per lo più è antichissimo. Con l'incontro di oggi non arriveremo a definire nulla: tenteremo semplicemente una ricerca augurandoci di stimolare curiosità, domande, interrogativi e di fornire alcuni possibili indirizzi e strumenti di analisi. Poiché, come vedremo, il mito della Grande Madre è un tema complesso, articolato, multidisciplinare, sarebbe interessante poter affrontare insieme , con altri incontri, ogni possibile percorso. Dialogare attorno a questo mito che si perde nella notte dei tempi significa addentrarsi nei domini dell'astronomia, della mitologia, della religione, della storia, delle arti figurative, dell' artigianato: insomma significa tentare di codificare diversi sistemi di segni attraverso i quali l'uomo fin dall' origine ha tentato di rappresentare il mondo. E la Grande Madre, per un periodo lunghissimo e lontanissimo è stata l'unica spiegazione che l' uomo potesse darsi dell' esistente. Una spiegazione che oltrepassa i confini dello spazio e del tempo. La Grande Madre, infatti come dicevo poco sopra, non coincide con una fenomenologia definita: è piuttosto un sentimento, un archetipo che sta dietro a diverse rappresentazioni; è il sentimento dell'energia creatrice, generativa che l'uomo scopre in sé e nel mondo agli albori della propria coscienza e che gli fa pensare che esista un dio, o….. una dea. Nonostante le sue origini siano antichissime, le sue tracce hanno viaggiato nel tempo giungendo fino a noi: basta solo volerle scoprire; nonostante la presenza di questo mito sia stata attestata prevalentemente in precisi contesti culturali, indagando si scopre che la Grande Madre ha conosciuto una diffusione ecumenica, cioè universale, fino a costituire una invariante antropologica comune a tutte le civiltà umane. Proviamo ad iniziare la nostra indagine chiedendoci per il momento a quando risale questo mito. Come vedremo successivamente, tracce archeologiche riconducibili al mito della Grande Madre risalgono a 250.000 anni fa: una distanza temporale significativa. Per capire il significato autentico e originario di questo mito, dovremmo forse sforzarci di abbandonare gli schemi attraverso cui conosciamo e interpretiamo la realtà che ci circonda e porci di fronte agli eventi della vita con gli occhi di un uomo primordiale, privo degli strumenti cognitivi, intellettuale e scientifici che noi tutti oggi possediamo; dovremmo focalizzare la nostra attenzione sulle cose dell'esistenza che oggi ci sembrano banali, insignificanti. Spesso mi sono chiesta come potesse reagire un uomo primitivo di fronte ad eventi straordinari come la gravidanza e il parto, la nascita di un bimbo, ma anche di un animale, o ancora come si desse spiegazione del germinare delle piante da terra e o sui rami degli alberi. E proviamo a pensare quali sensazioni potesse suscitare nell' uomo primitivo l' accadere della morte. Noi oggi per lo meno possediamo dei nomi, con cui designamo questi eventi: nemmeno noi contemporanei sappiamo cosa siano la vita e la morte, ma avendo imprigionato questi misteri nelle maglie del linguaggio, ci illudiamo di poterli conoscere. Per l'uomo primitivo, ciò che noi oggi ci illudiamo di conoscere, rimaneva invece un insieme misterioso di odori, visioni, sapori, rumori di fonte al quale non poteva che provare un sentimento panico, un misto di timore e fascino. Di fronte a questi insondabili misteri i primitivi hanno provato il sentimento del sacro. La Grande Madre, in sostanza potrebbe coincidere con questo sentimento: in questo mito, così complesso, nei millenni di storia, l'umanità potrebbe aver condensato tutte quelle immagini ed emozioni in qualche modo connesse alle manifestazioni della vita e della morte; essa rappresenta l' Alfa e l' Omega, la sacralità inviolabile, potente da cui sgorga, inesorabile e misteriosa la forza generatrice della totalità della vita. Proviamo ad immaginare come l' evento di una gravidanza potesse essere vissuto dalle comunità dei nostri antenati: un corpo femminile, misteriosamente si trasforma, si modifica; nell' arco di nove mesi il ventre si gonfia, si gonfiano anche i seni e da questa metamorfosi scaturisce una nuova vita. Che cosa rimane impresso nella mente di un primitivo? Presumibilmente la doppia metamorfosi del corpo femminile che prima si gonfia per ritornare poi uguale e se stesso; presumibilmente il flusso d' acqua che precede il parto vero e proprio. Ecco, soffermiamoci su questi fenomeni, la generatività, la ciclicità della trasformazioni, perché saranno proprio questi a fornirci le chiavi di lettura delle rappresentazioni più significative attraverso cui si è data forma all'archetipo della Grande Madre. Non credo che la conoscenza, né il pensiero primitivo avessero stabilito nessi biologici e logici tra l' esperienza sessuale e la generazione di un nuovo essere vivente. Solo la scienza moderna, nel 1700, ha ipotizzato e dimostrato l'esistenza di questi nessi. Il pensiero primitivo dimostra di essere diverso dal nostro, cioè da quello dominante nella cultura occidentale. Noi pensiamo utilizzando categoria logiche: c'è un prima e un dopo, un sopra e un sotto; c'è l'identico e il diverso, c'è la forma e c'è la sostanza, una causa e un effetto. Il pensiero primitivo sembra essere invece soprattutto analogico e più che interpretare per distinzioni in categorie, sembra procedere cogliendo le somiglianze. Seguendo il percorso di questo pensiero, se una nuova vita appare in seguito ad una metamorfosi, il mistero della vita, la Grande Madre sarà quella metamorfosi. Metamorfosi e partenogenesi, cioè riproduzione asessuata, possono costituire alcuni indicatori dietro i quali riconoscere il mito della Grande Madre. Guardiamo un esempio di statuetta steatopagica , FIG. 1 , in questo caso la VENERE DI WILLENDORF. Siamo di fronte ad un'opera scultorea realizzata 20.000 anni fa e rinvenuta in un contesto prossimo alla nostre aree, cioè in Austria. La tipologia morfologica è tuttavia diffusa in tutto il bacino del mediterraneo: testimonianze analoghe provengono dal contesto cicladico e l' inverno scorso, esemplari simili si sono rinvenuti sul fondo del lago di Bracciano, vicino a Roma e ancora più vicino a noi, sull' Altopiano di Asiago. Nonostante la statuetta sia stata catalogata sotto la denominazione di VENERE, vedendola non possiamo non pensare alla metamorfosi del corpo femminile attraversato dal mistero della vita: ventre e seni rigonfi ne sono i segni inconfondibili e dietro a questa piccola VENERE - cm 11,5 - c'è sicuramente la Grande Madre. Queste statuette erano oggetto di culto, erano oggetti sacri che presiedevano ai riti di fertilità; chi ha eseguito questo lavoro non voleva evidenziare una individualità – e infatti la statuetta è spersonalizzata da un volto indistinto -, ma una entità universale: nella forma di una donna segnata dalla gravidanza un uomo di 20.000 anni fa ha voluto rappresentare la forza generatrice del mondo. Tuffarsi in un passato di 20.000 anni, significa entrare nel paleolitico: l'uomo ancora caccia , si nutre di bacche e frutti selvatici, trova riparo casuale in grotte naturali ; ha elaborato una conoscenza tecnologica che gli consente di costruirsi gli utensili necessari alla caccia , gli stessi che probabilmente usa per scolpire la pietra e incidere le pareti delle caverne in cui alberga. Tuttavia, come ipotizza Giuseppe Sermonti , il processo che porta, lungo un cammino millenario, alla definizione morfologica delle statuette steatopagiche inizia ben 250.000 anni fa. Al periodo Acheulano risalgono ciottoli scheggiati FIG. 2 caratterizzati da una particolare curvatura, interpretabile come una curvatura lombare che designa l' ansa dei glutei. Ritroviamo il principio partenogenetico in altri contesti, lontani nel tempo e nello spazio da quello prima preso in esame. Esiodo, autore greco del VIII° sc. A. C. nella sua cosmogonia, opera letteraria che racconta gli inizi del cosmo, afferma che all' inizio di tutto era Gaia, Gea la terra: dalla sua forza creatrice, in modo asessuato Gaia genera Urano, il cielo stellato così da potersi fare abbracciare da lui e non essere più sola. Anche Yeba Belo o Ava, Grande Madre dei Desana del Vaupes brasiliano è all' origine di tutto: si autogenera con la forza del proprio pensiero. Successivamente, nutrendo la sua anima con fumo di sigaro e caca, genera i Cinque Tuoni, cui delega il compito di creare il mondo e gli uomini. Ava è sicuramente la più trasgressiva delle Grandi Madri; forse la più metafisica perché la sua forza generativa risiede nel suo pensiero. L'aggettivo di trasgressiva, riferito all' assunzione di coca, è una battuta. L' assunzione di erbe stupefacenti è invece intimamente collegata ai sistemi culturali e ambientali di ogni civiltà, soprattutto, a quelle caratterizzate da forme di religiosità sciamaniche, caratterizzate da momenti rituali in cui grazie appunto all' assunzione di sostanze stupefacenti, si entra in uno stato di trance che libera dalla coscienza, ovvero di ciò che individuando l'uomo, lo distingue dal mondo, per ritrovare l'originaria fusione con esso. La metamorfosi come principio generativo, ritorna nel bacino del mediterraneo, in età neolitica, circa 10.000 anni fa.. Nel sito turco di Catal Huyuk, composto da unità abitative e templi, le superfici di questi ultimi sono decorate da affascinanti cicli di affreschi. Uno di questi è stato catalogato coma "" La nascita della Grande Madre "" FIG. 3. L'affresco, come indica Giuseppe Sermonti2 va letto in senso orizzontale, iniziando dalla bande laterali e procedendo fino a quella centrale. Iniziamo da qui, per riconoscere una morfologia già nota: una figura femminile steatopagica, assisa: una Grande Madre quindi. Alla definizione di questa sagoma si giunge progressivamente attraverso passaggi metamorfici che partono dai lati, dove è possibile riconoscere una sequenza di forme che richiamano chiaramente i genitali maschili: il mito è chiaro: la Grande Madre di Catal Huyuk è generata dalla metamorfosi dei genitali maschili. Non si po' non notare la strettissima analogia con la cosmogonia di Esiodo, composta quasi 9.000 anno dopo questo affresco anatolico. Esiodo racconta che Gea, disperata per il comportamento di Urano assassino di quasi tutti i loro figli, organizzò con Krono, uno dei pochi suoi figli sopravvissuti, di evirare Urano. Così accadde; i genitali del dio furono gettati nel mare e dal loro contatto con la schiuma marina si generò Afrodite Urania. Ma anche osservando contesti culturali a noi più vicini, la cultura cristiana, scopriamo la permanenza di miti partenogenetici: Gesù è frutto di una immacolata concezione e anche S. Anna, a quanto ci dicono alcuni vangeli apocrifi, concepisce Maria in modo misterioso, visto che Gioacchino rimane nel deserto, lontano dalla moglie per una lungo periodo. Quindi metamorfosi e partenogenesi principi generativi attribuiti alla Grande Madre. A partire dall'età neolitica si configura un altro attributo al mito: l'identificazione con l'acqua, tutte le manifestazioni che la possono ricordare, e soprattutto la terra. Non è casuale che questo avvenga appunto in età neolitica, periodo collocato indicativamente intorno ai 10.000 anni fa, e durante il quale l'umanità consolida definitivamente l'uso agricolo della terra. A questa pratica l' uomo deve essere giunto gradualmente, forse in modo casuale, sperimentando, applicando e sviluppando le tecniche agricole. L'uso agricolo della terra rappresenta una rivoluzione economica e sociale: i gruppi umani devono essere vincolati al suolo che coltivano; iniziano quindi a stanziarsi e a raggrupparsi in piccole comunità, in villaggi; l'umanità scopre progressivamente i vantaggi dello stare sociale, delle regole della vita comunitaria. E' soprattutto in corrispondenza di significativi corsi d'acqua, che si insediano queste prime comunità agricole, grazie alla fertilità del suolo irrigato e fertilizzato dalle naturali dinamiche dei fiumi. E' presumibile che fin dal Paleolitico sia stata la donna a tramandare le conoscenze relative alle piante: l' inferiore forza fisica rispetto ai maschi la rendeva meno adeguata ad occuparsi di caccia. Quando ancora non si viveva di agricoltura, ma di raccolta, la capacità di distinguere piante commestibili da quelle velenose, la conoscenza delle dosi opportune in cui mescolare foglie, radici e bacche era essenziale alla sopravvivenza: sbagliare una pianta o un dosaggio poteva essere letale. E' probabile che questa ripartizione dei compiti tra uomini e donne si sia consolidata anche in epoche successiva, nonostante la crescente complessità sociale introducesse nuovi criteri di distribuzione dei ruoli. In seguito a questa tradizione proprio la figura femminile avrebbe accumulato e tramandato i segreti della farmacopea, essenziali alla pratiche di riti sciamanici e taumaturgici, cioè curativi. L' identificazione della Grande madre con l'acqua, e con tutto ciò che la richiami morfologicamente rimane in un culto a tutti noto: mi riferisco a Lourdes. Questo luogo è morfologicamente molto particolare: una caverna naturale con all' interno una sorgente d'acqua. L'archeologia ci ha testimoniato di molti rituali localizzati in prossimità di sorgenti o grotte; non è casuale che la pastorella di Fatima abbia visto proprio qui la Santa Vergine: il luogo doveva essere sacro da una tradizione millenaria e la densità di siti paleolitici nella regione di Luordes, in generale in tutta la Spagna settentrionale – grotte di Altamira – e nelle Francia meridionale - grotte di Lescaux – rende credibile questa ipotesi. L' identificazione della Grande madre con l'acqua, è alla base della suggestiva ipotesi formulata da Giuseppe Sermonti relativa l' origine della Via Lattea, o meglio, della codificazione di quell'insieme splendente di stelle che attraversa sinuoso come un fiume lo spazio del firmamento. Nelle notti primitive, non ancora intaccate dall' inquinamento luminoso , quell' ammasso fluente , bianco che attraversava il cielo poteva ricordare ai nostri antenati il flusso dell'acqua che precede il parto; quello del fiume da cui si originano i fertili depositi di limo. Sermonti fa notare che sul piano dell' eclittica la via lattea si incontra con la costellazione dei Gemini, due stelle simili per splendore e grandezza. Questa struttura – un flusso centrale al cui inizio si stagliano, quasi a fare da guardiane , due figure gemelle, potrebbe costituire un archetipo attraverso cui da millenni – secondo i calcoli astronomici proposti da Sermonti almeno da 22.000 anni – l' umanità rappresenta la Grande Madre, il principio generativo delle cose. Ritorna, ad esempio, la medesima struttura, in una statuetta in terracotta proveniente dal sito di Catal Huyuk FIG. 4 : la figura centrale, questa donna dal corpo greve, appesantito dalla vita che lo attraversa, è assisa in trono: è un Grande Madre – commovente che una figura tozza, i seni penduli, il ventre gonfio, la corporatura massiccia, sia sacralizzata al di là di ogni canone estetico: la sua bellezza è nel mistero impetuoso che la plasma - ; ai lati del trono, simmetrici rispetto alla figura centrale due protomi, di agnelli forse, o qualcos'altro. Non è questo ad interessarci, ma la struttura: una Grande Madre centrale e due figure gemine laterali, esattamente analoga alla via lattea in intersezione con Gemini. Spostiamoci ora in un altro contesto culturale, Micene, 1800 anni a.C. e soffermiamoci su una delle porte cittadine FIG. 5 : sull' architrave due leoni gemini e simmetrici posti a guardia dell'accesso alla comunità. Dall' età neolitica, a cui risalgono i primi insediamenti stanziali, il villaggio acquista valenze multiple: è la sede dell'identità del gruppo, è il luogo dell'appartenenza, è il rifugio dove sono conservate le scorte alimentari; ad esso si contrappone tutto quanto ne esula, l' esterno incolto, pericoloso, sconosciuto, desertico. La Grande Madre è l' entità fondatrice e protettrice del villaggio, per rappresentarla gli Achei di Micene hanno attinto ad un archetipo tramandato da millenni. E la ricorrenza di questa struttura, derivata da una primordiale codifica della fenomenologia astrale, imperniata sulla identificazione Grande Madre – Acqua, si ritrova millenni dopo nella mitologia greca; Cibele, la Grande Madre frigia ha al suo servizio la coppia dei Dioscuri Castore e Polluce: ancora una Grande Madre accompagnata da una coppia gemina. Si diceva che a partire dall'età neolitica il principio generativo inizia ad essere associato alla terra oltre che all' acqua. Troviamo la Grande Madre in sembianze di creature ctonie, sotterranee, cioè legate alla terra - serpi, draghi - in due opere di contesto babilonese, le prime opere scritte dell' umanità. L' Epopea di Gilgamesch e L'Epopea della creazione risalgono all'inizio del 2° millennio a.C. e sono state incise su tavolette di argilla in caratteri cuneiformi. Nell' Epopea della Creazione, all'origine di tutto c'è Tiamat, dragonessa cui spetta il compito di creare il mondo. Nell' Epopea di Gilgamesch il riferimento alla Grande Madre è indiretto. L'epopea racconta le gesta di Gilgamesch, creatura semidivina, eroe di una civiltà ormai evoluta, ormai lontana dalla natura originaria. Nel confronto con Enki suo alterego, Gilgamesch tradisce la nostalgia della sua civiltà per le lontane origini perdute. Nel corso del racconto Enki muore; Gilgamesch, disperato per il lutto, affronta una serie di peripezie alla ricerca della pianta della vita eterna; la trova, immersa nell'acqua di un fiume; è sua, ma improvvisamente dal letto del fiume una serpe emerge e gliela ruba per sempre. Solo alla serpe, ctonia sembianza della Grande Madre, può spettare il segreto dell'immortalità. Nella mitologia greca le figure ctonie femminili sono numerose: Pitone, primo oracolo di Delfi, è una serpe cui il mito attribuisce i misteri della saggezza e i poteri divinatori; Latone è una serpentessa avvinghiata ad un albero nel giardino di Occidente: ella presiede alle Esperidi, ninfe crepuscolari, guardiane del giardino e soprattutto delle mele d'oro che fruttificano dai suoi alberi. E' immediato un riferimento all'Eden biblico, al serpente avvitato all' albero sacro della conoscenza. Questa morfologia travalica i confini del tempo e dello spazio; una fiaba medievale, di derivazione latina, Melusina, racconta di una principessa FIG. 6. È molto bella, saggia, prolifica; fa dissodare la terra, ma ha un segreto: ogni sabato deve scomparire per immergersi in uno specchio d'acqua dove si trasforma in una creatura per metà donna e per metà drago. Anche nella nostra tradizione orale esistono figure analoghe, le anguane, per esempio. Sono donne semidivine che incantano con la loro bellezza i comuni mortali, si danno al loro amore a patto che rispettino il loro segreto: anche le anguane, una volta alla settimana devono sparire per immergersi in uno specchio d'acqua, dove, tramutandosi in serpi, si rigenerano. Un siffatto specchio d'acqua, magico e sacro è attestato anche dalle nostre tradizioni locali, che lo identificano con il Subiolo, a Valstagna. L'identificazione del principio generativo con la terra è esplicita nella cosmogonia di Esiodo, dove , come abbiamo già visto, il principio originario e creatore è Gea, Gaia, cioè la terra. Anche gli alberi costituiscono un richiamo alla terra: essi vi affondano le radici traendone nutrimento per produrre fiori e frutti. Nelle mitologie nordiche la sacralizzazione dell'albero o del bosco è ricorrente: molte figure magiche, come le fate, soprattutto della tradizione gallica, sono signore e protettrici dei boschi. In uno dei miti greci dedicati ad Atena, le dea è compete con Poseidone per il controllo su Atene. E' la divinità femminile a vincere, donando alla città l'albero dell'ulivo, divenuto sacro. Dietro all' Eretteio, nell' Acropoli di Atene, un recinto sacro circonda l'antico luogo dove sarebbe comparso il primo ulivo. Un residuo della identificazione Grande Madre – albero è forse rintracciabile nella tradizione, consolidata anche nel nostro territorio, delle madonne arboree. Epifanie, cioè comparse, della Vergine Maria sulle chiome di un albero o nelle sue adiacenze sono testimoniate nelle tradizioni locali di tutta la penisola; all' albero così beatificato, si appendono ex voto o si accostano cappelle votive, i nostri capitelli. Anche nel nostro territorio non è raro trovare un capitello affiancato ad un albero, soprattutto carpini. Un' altra peculiarità dei capitelli ci riconduce alla Grande Madre: essi sono localizzati sempre in corrispondenza di bivi o trivi, insomma in corrispondenza di un crocevia. Questo luogo deve aver assunto per le culture arcaiche pregnanti significati esoterici e religiosi. I crocicchi erano presieduti nella mitologia greca da divinità complesse e misteriose, come Hermes o Ecate, il cui culto nel nostro territorio è attestato fin dall'epoca preromana, Ecate, arcana, potente, diurna e notturna e le sue orchesse, tra cui Empusa sono un residuo della Grande Madre primitiva; esse possono arrecare all' uomo benefici o malefici. Da qui l' esigenza di doni votivi per ingraziarsi i poteri soprannaturali. Anche in culture estranee a quella occidentale, per esempio africane, i crocevia assumono il medesimo significato e hanno prodotto nei secoli analoghe manifestazioni votive. Ulteriore attributo della Dea Madre è il ritorno, l'inesorabile ritorno ciclico. Cicliche sono le fasi lunari; cicliche sono le maree; ciclico è il sorgere e il tramontare del sole, cicliche ancora, sono le stagioni, ciclica è la vita che si frange nella morte per poi rinascerne. Non è casuale che per esempio la Madonna arborea di Bagni, in Umbria, si presenti con un'iconografia che la associa al falcetto lunare. Ma il mito più eloquente è forse quello greco di Demetra. Demetra è una delle divinità olimpiche, figlia di Rea e Krono. È madre di piante e animali e spesso si manifesta in sembianze di spiga o giumenta: è quindi legata alla terra e ai suoi cicli. Demetra ha una giovane figlia, Persefone che un giorno le viene rapita da Ade, dio degli inferi. Demetra inizia la ricerca affannosa della figlia; per il dolore e la rabbia, rende sterile la terra. La situazione si protrae al punto che gli esseri umani non hanno più alcun bene da offrire agli dei. Interviene allora Zeus, che consentirà a Persefone di riemergere dagli inferi, ai quali dovrà però tornare per un terzo dell' anno. Durante questo periodo Demetra, rimpiangerà la figlia impedendo alla natura ogni germoglio. Dietro a questo mito, si ravvisa il ciclico divenire stagionale, che alterna a periodi di fecondità, come la primavera, l' estate, l'autunno, periodi in cui la terra sembra assopirsi e quasi morire. Nel mito di Trittolemo, Demetra è la divinità che dona agli uomini i cereali, e per questo le saranno tributati i culti eleusini. Ma nella narrazione Demetra compie un gesto che la collega , come un filo diretto, a Taniquilla, figura della mitologia latina e poi a Melusina, che abbiamo già incontrato come protagonista di una fiaba francese medievale. Tutte e tre hanno a che fare con un neonato maschio: Demetra con Trittolemo, Taniquilla con Servio, figlio di una sua ancella e futuro re di Roma, e Melusina con gli ultimi suoi due figli. Tutte e tre, di notte accudendo il neonato lo avvicinano al fuoco; Demetra e Melusina lo allattano anche. Come interpretare questo gesto ricorrente in contesti culturali così lontani? Possiamo pensare che i racconti alludano o conservino la memoria di lontani rituali che vedevano coinvolti i neonati? I resti neolitici provenienti da un sito italiano, la grotta dei Piccioni in Basilicata, sembrano confermare questa ipotesi e venarla di colori cupi; essi attesterebbero riti legati alla fertilità, alla semina durante i quali per propiziarsi il favore delle energie sovrannaturali si sacrificavano neonati e bambini. Fin qui si è cercato di evidenziare le ricorrenza di invariante antropologica di questo mito, come si è visto , antichissimo. Un ricorrenza oltre i confini del tempo e dello spazio; una continuità su cui poter riflettere. Questo mito sembra costituire un archetipo della mente umana, una forma del pensiero, antica che per millenni ha sostenuto l'uomo nella interpretazione di sé e del mondo. E se essa potesse ancor oggi costituire per l'essere umano una alternativa, una visione su se stesso e sulle cose, complementare a quella sviluppatasi nell'epoca contemporanea? 2. La materia: il luogo della Grande Madre. Il titolo di questo incontro, LA MATERIA: LUOGO DELLA GRANDE MADRE , risulta riduttivo oggi rispetto al contenuto , che dallo scorso autunno ho modificato sulla scorta di due avvenimenti. Il primo è il conferimento del premio nobel per la pace dello scorso anno, alla signora keniota. K. Mootai. Questa donna si è vista insignita del prestigioso riconoscimento internazionale sostanzialmente per aver piantumato, nel corso di dieci anni, trenta milioni di alberi sui clivi del Monte Kenia, coinvolgendo in questa iniziativa gruppi di donne, togliendole da un destino di emarginazione sociale e sfruttamento. In una intervista rilasciata al corriere della sera il 9 ottobre, la Mootai lascia intravedere nelle motivazioni etiche e religiose sottese alla sua iniziativa, un richiamo ad un sapere, ad una religione antica; la sue parole sono "" una volta la gente credeva che gli dei abitassero il Monte Kenia e lo veneravano; adesso si dicono cristiani, vogliono andare il paradiso e distruggono la fonte della loro vita "". Il secondo avvenimento è la tragedia provocata dallo Tzunami, in particolar modo l'esito di questo che questo fenomeno naturale ha avuto sulla popolazione andamana: i pochi abitanti di queste isole, colpite in pieno dall'onda, sono sopravvissuti in percentuali altissime; caratteristica di questa popolazione, formalmente sotto giurisdizione indiana, è di aver rifiutato anche violentemente qualunque forma di contatto e assimilazione ai modelli oggi definiti globali. Li ha salvati un sapere antico: hanno riconosciuto immediatamente il pericolo nella profonda risacca del mare; hanno saputo dove rifugiarsi; le loro abitazione sono sempre state edificate oltre una certa linea dalla costa e in materiali leggeri – il legno -. Alla luce di questi due avvenimenti, accomunati dal recupero ovvero preservazione delle tradizioni arcaiche, quindi, come cercheremo di vedere, del mito della Dea Madre, viene da chiedersi se un ritorno alla nostra mente antica non possa rappresentare per l'uomo contemporaneo, una auspicabile prossima frontiera. Il percorso di questa lettura sarà quindi il seguente: a) cercheremo di chiarire cosa si intenda per Grande Madre da una prospettiva iconografica e storica; b) vedremo, con l'ausilio della ricerca svolta da Tiziana, come elaborato di tesi di laurea, che quanto definiamo Grande Madre, almeno nelle sue manifestazioni iconografiche, è rimasto nel tempo, celata forse nelle profondità della nostra mente , fino ai giorni nostri c) vorremmo cercare di indagare il significato originario di quelle traccia del passato che le scienze umane contemporanee hanno classificato con la denominazione di Grande madre – Dea Madre; d) Cercheremmo di individuare alcuni possibili fattori che nella storia della civiltà occidentale, hanno contribuito a spezzare la continuità storica di questa forma mentale; 2. a ) La Grande Madre in una prospettiva storico-iconografica In questa prospettiva definiamo prime tracce storico-iconografiche della Grande Madre, gli oggetti di culto configuratisi nella morfologia delle Veneri steatopagiche di cui abbiamo già visto un esempio nel primo paragrafo. Riprendiamo brevemente questo argomento: le testimonianze più antiche di questa tipologia di manufatto risalgono a 30.000 anni fa, al paleolitico, almeno per l'ambito europeo- mediterraneo, in cui questa tipologia di oggetto ricorre senza differenziazioni significative dalle aree occidentali – Spagna – a quelle orientali – Malta, a quelle più settentrionali – Austria, Lazio ed è allo studio in questo periodo un reperto proveniente dall'Altopiano di Asiago -. Il significato storico di questi manufatti è indiscutibile, poiché essi documentano una identità culturale distribuita su un a territorio molto ampio, dal mediterraneo al continente europeo centrale ed occidentale, nello stesso arco temporale – il paleolitico -, identità verificabile sulla scorta dell'analogia morfologica e tecnico-linguistica di questi oggetti. Analogamente alle scritture più antiche – il cuneiforme mesopotamico – così queste morfologie hanno fornito all'evoluzione dei linguaggi visivi, criteri e strutture compositive, e i relativi rinvii semantici. Il tema/la poetica della Grande Madre si ravvisa lungo un asse diacronico temporale e sincronico spaziale, quasi senza soluzione di continuità; linguaggi visivi lontani millenni, dall'arte del paleolitico, ne hanno sorprendentemente conservato i criteri compositivi. Anche le immagini di miti e leggende, modi di trasmissione culturale potremmo dire fossili, confluiscono nella ricerca dell'arte contemporanea. L'installazione dell' Artista Yufen, del 1994, Primavera di giada, con i suoi panni stesi in un cortile attorniato da sculture femminili classiche, sembra riprendere un soggetto legato alle leggende dei nostri luoghi sulle Anguane, queste misteriose deità femminile, molto complesse, legate alla simbologia rigenerativa dell' acqua. In molte leggende infatti, quelle legate alla grotta il Buso della rana a Priabona, al subiolo di Valstagna, al castello di Marostica queste deità compiono un gesto che probabilmente è rituale: stendono i panni. Lo stesso gesto è di Nausica, la principessa di Scheria che accoglie Ulisse dopo l'ennesimo naufragio. 2. b ) La grande Madre: archetipo del sentimento del sacro Torniamo ai manufatti paleolitici. L'indagine comparata dei dati storici e antropologici conduce al risultato condiviso che si tratti di oggetti rituali, oggetti di culto: non si ravvisa infatti nella loro struttura nessuna finalità funzionale-operativa; sono oggetti comunicativi, rappresentano qualche cosa. Ma che cosa rappresentano? Molti studi relativi a questo soggetto hanno fornito la denominazione Grande Madre – Dea Madre per rispondere a questo interrogativo, ma si tratta di una concettualizzazione postuma ovviamente rispetto alla originaria attribuzione di senso. Ma possiamo affermare con certezza che l'artefice di questo oggetti, che ricordiamolo risalgono anche a 30.000 anni fa, volesse significare esattamente ciò che noi oggi intendiamo con il concetto MADRE, o con il concetto DEA? I dubbi sulla correttezza, o meglio sulla effettiva corrispondenza di questa definizione al significato originario di questi manufatti è legittimato da alcune considerazioni di vario ordine, in particolare di ordine storico, antropologico e linguistico. La considerazione di ordine storico è la seguente: come abbiamo già avuto modo di vedere precedentemente, dobbiamo anticipare di quasi 200.000 anni la produzione di manufatti presumibilmente connessi ai tratti morfologici e semantici delle statuette paleolitiche viste prima. G. Sermonti infatti ravvisa già nelle cosiddette AMIGDALE , risalenti all'Acheulano, 250.000, quella morfologia a profonde rientranze e pronunciate sporgenze che raggiunge la sua perfezione plastica appunto nelle statue paleolitiche. Abbiamo a che fare quindi con un Sapiens Sapiens veramente molto lontano da noi Per quianto riguarda la riflessione più specificatamente antropologica, si deve comunque partire dalle parole. Il sostantivo attuale di MADRE rinvia ad una stratificazione semantica molto complessa, in cui riferimenti psicologico-affettivi si sovrappongono a riferimenti di contenuto sociale. La parola madre indica un'entità certamente affettiva, che si distingue però anche come ruolo definito e riconosciuto socialmente. Ci dobbiamo chiede se questa parola e le sue connessioni semantiche esistano già 250.000 anni fa e ponendoci questo quesito dobbiamo interrogarci inevitabilmente sulla storia del tabù dell' incesto. Il tabù dell'incesto distingue l' organizzazione delle strutture sociali animali da quelle umane, ma possiamo affermare con certezza che l'autore delle amigdale e delle statuette di cui sopra fosse un uomo la cui mente avava già elaborato-interiorizzato questo tabù? Se così non fosse questi manufatti non possono rappresentare una MADRE, - perché ancora questo ruolo affettivo e sociale non esiste - , ma qualcos'altro. Cosa? Per cercare di capire possiamo comparare altri manufatti contemporanei alle "" grandi madri "" paleolitiche, anch'essi oggetti di culto. Esiste una correlazione tra questi manufatti e le cosiddette dee madri? Veniamo alla terza e ultima considerazione di natura linguistica . Esiste una continuità etimologica e semantica tra le parole latine MATER E MATERIA: Semerano spiega questa continuità con questa analisi : MATER: sanscrito MATA, antico slavo MATI , lettone MATE, sumero AMATU = GENERATRICE, GENERANTE; accadico WATRU – MATRU = prominente, sporgente, grosso, della stessa radice di MATARU-ATARU = ingrandire. Per le corrispondenze in accadico tra W/M/B e quindi tra ATRU, MATRU, WATRU, UTRU, si chiarisce che MATER, VENTER, UTERUS, derivano dalla stessa base, cosi anche il latino MATURUS = che ha avuto il suo sviluppo ( in seguito ad un cambiamento ) – MATERIA - AE = sostanza da cui qualcosa deriva, principio delle cose, ad esempio il tronco d'albero che produce rampolli ( in greco reso da ??? = parte ombrosa di una selva, sterpaglia per il fuoco, accadico SULULU = oscuro, sumero UL che richiama accadico ALAPU, ELEPU = germogliare. Che cosa si può non concludere, ma osservare alla luce di queste riflessioni? Possiamo ancora risolvere il mistero del loro senso, nella forma di un corpo femminile gravido? Questi antichi manufatti sono oggetti rituali, oggetti di culto; essi rappresentano qualcosa di sacro, forse anche oggetti sacrificali = ex voto. Che cosa è sacro per questo antichi uomini? Su che cosa si debba intendere per SACRO sono stati scritti fiumi di parole. Certamente i processi di sacralizzazione sono di natura culturale, quindi soggetti a variazioni sincroniche nell' asse dello spazio e diacroniche lungo l'asse del tempo, e soggetti anche a persistenze che producono invarianti. Tentare di capire oggi cosa potesse risultare sacro ad un uomo di 250.000 anni fa risulta difficile, ma forse non impossibile, visto che certe forme antichissime ritornano, come abbiamo visto per le arti visive, a distanze temporali veramente notevoli. Durante questa indagine è utile tenere presente che l'uomo di cui ci stiamo occupando si colloca al remoto esordio della cultura; ciò che la nostra tradizione culturale ci rende ovvio, per quest'uomo antico è ancora oggetto di curiosità, di quella "" brama di conoscenza oggettiva "" , di cui parla Levi Strass per descrivere l'attitudene del pensiero dei popoli cosiddetti allo stato di natura. Non ci sono ancora SIGNIFICATI, ma solo ESPERIENZE da attraversare, conoscere. Il sacro per quest'uomo, è una condizione pregressa a qualunque domanda sul mondo; la domanda è infatti un atto linguistico che presuppone la risposta, mentre il tempo in cui stiamo cercando di entrare, risposte ancora non ne ha. La nascita, la morte, la crescita, le variazioni metereologiche, le innumerevoli fenomenologie naturali: l'uomo di cui stiamo parlando non sa ancora che cosa sono, non sa perché avvengano, non ne conosce le conseguenze. Il suo pensiero funziona secondo dinamiche prevalentemente analogiche, non logiche: categorie come sopra-sotto; prima – dopo; diverso-uguale non organizzano ancota la sua conoscenza, che invece si costruisce soprattutto per somiglianze. Cosa accomuna morte, nascita, crescita, stagioni, giorno, notte, inverno freddo, estati calde, giornate torride e insopportabili siccità ? Il cambiamento; la materia tutta, si manifesti nella forma del corpo umano, di quelli animali e vegetali, nel succedersi dì-notte, e delle stagioni, condivide un unico medesimo processo, cioè la trasformazione, la metamorfosi da una forma in un'altra. Ciò non sfugge alla "" brama di conoscenza oggettiva "" di quest'uomo primordiale, ma contemporaneamente tutto quanto si svolge all'attenzione dei suoi sensi o attraversa il suo corpo, prescinde la sua volontà, non si spiega, non rivela la sua origine, né il suo fine. Questo inesorabile silenzio spaventa, lascia stupefatti, fa sentire impotenti. Forse il SACRO è proprio il sentimento di smarrimento, fascinazione, terrore, rabbia che la coscienza umana è destinata a provare sempre di fronte a ciò che la limita, ad una alterità ineffabile e incontrollabile. Possiamo pensare che per gli antichi, questa alterità sia la totalità della materia, ancora non logicamente conosciuta, e in particolar modo la sua natura metamorfica senza inizio e senza fine. L'osservazione della morfologia delle statuette ci presenta con insistente frequenza un processo, un processo di cambiamento attraverso la materia di un corpo, il corpo femminile, che più di quello maschile conosce il mutamento. Esso progressivamente muta, crescendo si trasforma, diventa altro da sé: seno e ventre si gonfiano, i piedi si allargano per sostenere il peso crescente, la schiena si incurva per il peso; smette il flusso sanguigno, iniziano le perdite lattee del seno: il corpo femminile, forse prime ancora di assumere il ruolo che oggi definiamo con il termine di MADRE è una sintesi massima di metamorfosi. Il ventre improvvisamente diventa una sorgente di acqua e poi dopo ore, giorni di dolore immotivato il ventre si trasforma in un nuovo essere umano. Il corpo femminile oltre ad essere una sintesi massima di metamorfosi è anche una metamorfosi generativa, ma per trasformarsi in quel nuovo essere, il ventre gonfio, quella forma ha dovuto sparire: la trasformazione vincola inesorabilmente la comparsa alla scomparsa. Anche oggi quella scomparsa è percepita e sofferta dalla madre, come un lutto una perdita che si configura nella diagnosi della depressione post partum. Prima ancora di ricevere il significato di madre, il corpo femminile rappresenta per gli antichi nella maniera più esauriente il divenire generativo da cui tutta la materia è attraversata sotto l'occhio curioso, attento, intelligente e spaventato dei nostri progenitori. Questa ipotesi può forse avvalorarsi prendendo in esame altri esempi di manufatti paleolitici, quali ad esempio il graffito definito "" SCIAMANO e la statuetta "" UOMO LEONE "" : non rappresentano anch'essi una metamorfosi, una trasformazione da una sostanza – umana – ad un'altra – animale- ? Il sentimento del sacro rappresenta la soglia che spartisce il mondo animale da quello umano. Esso è connesso con i procedimenti psichici della coscienza: l'uomo elabora il sentimento del sacro dal momento in cui, nuove sinapsi gli consentono di essere consapevole, attraverso l'esperienza personale e la sua analogia con le fenomenologie naturali, della vita e della morte. Questi eventi che prescindono l'uomo e la sua coscienza per attuarsi attraverso il suo corpo, inducono nell'uomo sentimenti e pulsioni potenti, riconducibili da una parte al piacere, al desiderio di vita, dall'altra all'orrore, il ribrezzo, la paura della morte; esse si risolvono in uno sommesso stupore di fronte all'insondabile e inesorabile a priori della materia che diventa il luogo del sacro. Nei più diversi contesti culturali, lontano nello spazio e nel tempo, le diverse rappresentazioni della Grande Madre, ci ciungano esse in forma di manufatto, di mito, di leggenda, di divinità condividono alcuni tratti salienti ad primo fra tutti la intima connessione con le dinamiche fondanti della materia, cioè l'andatura ciclica e cangiante, metamorfica; si pensi ai cicli mestruali, lunari, stagionali, solari, delle maree; ai cicli vitali della nascita, crescita, invecchiamento, morte, ai cicli biologici che dalla putrefazione di alcune molecole ne generano altre. E' presumibile quindi che la religiosità primitiva sia estremamente concreta, imperniandosi sostanzialmente sulla sacralizzazione della materia, delle sue fenomenologie, delle sue dinamiche. La conoscenza storica di periodi cosi' lontani è inevitabilmente lacunosa; le sue ricostruzioni possono essere solo ipotetiche e deduttive. Sappiamo, da studi antropologici e psicologici, che le strutture valoriali religiose, legate al sentimento del sacro, costituiscono nella psiche umana la struttura profonda e portante su cui si innestano sistemi più superficiali, quello etico e quello giuridico. Guardiamo ad esempio, quanto il tabù dell'incesto è stato determinante nella definizione dei ruoli sociali e dei relativi comportamenti etici. Da questo esempio si può quindi dedurre che il culto della materia abbia in epoche lontanissime determinato precisi codici comportamentali, individuali e collettivi, concretizzatesi in un rapporto devoto e rispettoso nei confronti della innumerevoli manifestazioni della materia. Le popolazioni nomadi di stirpe germanica, prima di essere latinizzate e in seguito cristianizzate, avevano individuato nell'albero la forma del sacro; l'albero era per loro un totem, un tabù. L'abbattimento di alberi era regolato da precise norme e rituali, la cui violazione prevedeva pene cruente e orribili. L'uso dell'acqua, di albero di ulivo, del fuoco; l'uccisione di animali è sempre stata regolata nelle culture antiche da rigidi sistemi normativi e rituali. Possiamo dire, che queste pratiche abbiano garantito alle generazioni passate, ciò che la civiltà contemporanea affannatamene cerca di ripristinare cioè uno "" SVILUPPO SOSTENIBILE "" 3. Soluzioni di continuità dell'antico archetipo: la civiltà produce nuove forme di sacro La civiltà occidentale da tempo ha perso questa modalità religiosa, questo particolare sentimento del sacro, di cui ultima testimone è stata, per molti studiosi, la cultura greca. Che cosa è successo? Quli possono essere stati i fattori che hanno allontanato l'uomo occidentale dalla MATERIA SACRA. Poichè la partita si gioca nell'ambito del sacro, è forse lì che si deve indagare e si scopre che il pensiero occidentale si caratterizza per l'elaborazione di una peculiare forma di religione: la religione rivelata. Le religioni rivelate o abramitiche, riconducibili tutte e tre alla parola di Abramo hanno consegnato all'umanità una parola, non una esperienza, nemmeno un interrogativo, bensì una risposta: DIO. Questa parola è molto particolarem, perché in molte lingue antiche, manca di un referente ed è solo una tautologia di se stessa. – DEUS lat. ; T??? gr. DI'U acc = cripta, stele in una cripta che si sovrappone, escludendolo a DIR-DIMIR, DIMER sumero = dio DEVAH, sanscr. = celeste – Dio è solo un concetto, autoreferenziale, virtuale, che per le sue caratteristiche di astrattezza, di metafisicità, di eternità, in finitezza ecc…consente alla mente umana di sottrarsi all' impotenza di fronte alla incomprensibilità, al mistero, alla assoluta prescindibilità della materia rispetto alla volontà e alla coscienza umana; consente alla menta umana un solipsismo che la risparmia dalla morte e la proietta oltre il fisico, nell'eterna immortalità della metafisica. Con le religioni rivelate, probabilmente l'orrore insostenibile della morte e l'inaccettabile impotenza di fronte alla vita, la coscienza dell' individualità e dei suoi limiti inisorabili, inducono l'omo ad elaborare una cultura che spezza la continuità tra l'uomo e il mondo, basata sulla materia, il corpo, e elabora una continuità tra l'uomo e Dio. Il sacro a questo punto è estirpato dalla materia, dalla natura – phisis - e collocato in una dimensione meta-fisica, sovrannaturale. Dio e materia sono per la prima volta scissi; compare in queste religioni una figura nuova, quella del DIAVOLO, ovvero DIA BELLEI, gr. separare, il reietto, il separato da dio, il sovrano della materia contrapposto all' imperatore celeste. Non è casuale che a questa nuova figura si attribuiscano nel corso dei secoli tutte quelle immagini che, nelle antiche religioni, evocavano la materia creatrice: le metamorfosi – il diavolo ha sempre attributi animali o assume sembianze diverse – ad esempio; la collocazione sotterranea, come le primigenie deità ctonie.Contro l'ingannevole e duplice fenomenologia della Grande Madre, oramai demonizzata la quale, nel suo ciclico divenire nasconde, dietro il miracolo della vita, il baratro della morte, il nuovo dio è garante di un cammino lineare ed escatologico che conduce all'eternità. La sostanza della vita si modifica: essa non è più un alfa e un omega, individuati dalla nascita e dalla morte di un corpo, ma la salvezza eterna dell'anima. La capacità di inventare –creare qualche cosa dal nulla, ovvero la capacità di fantasticare, di astrarre, di creare parole è indubbiamente la facoltà che distingue l'uomo dagli altri essere viventi e d è la sua caratteristica più grandiosa ed esaltante, ma può degenerare in una fantasmagoria totalmente scissa, dissociata dalla realtà, in cui l'uomo si illude, si illude soltanto di vivere. La civiltà sostiene queste convinzioni da circa cinque mila anni; esse non hanno risolto alla radice il problema, ovvero la inesorabile contingenza della fine, ma hanno sicuramente radicato una forma mentis che finalmente ha esorcizzato l'orrido della morte, collocandolo lontano dalla verità. La morte non fa più paura, non è più sacra, con essa si può giocare quotidianamente, non turba più alcuna coscienza, rassicurata da millenarie promesse di eternità. L'allontanamento della morte l'illusione che esse non esiste perché la verità della vita risiede nell'anima, ha paradossalmente prodotto un'attitudine mortifera nei sistemi etici più recenti dell' occidente e dell'Islam. Nonostante le conquiste del progresso – tecniche, civili, scientifiche – la nostra civiltà non è meno mortifera di quanto lo fossero le civiltà precedenti, anzi, considerando morte anche quella di esseri viventi non umani, forse le civiltà abramitiche sono di gran lunga più mortifere di quelle che hanno precedute. Il processo di industrializzazione-mercantilizzazione dei sistemi economici, avviatosi quattro secoli fa in Europa, costituisce un ulteriore percorso di allontanamento dell'uomo dalla natura, materia. Nelle economie naturali il rapporto con le risorse è diretto, immediato; in questo sistema il soddisfacimento dei bisogni è intrinsecabilmente legato alla tutela delle risorse: nella storia economica europea preindustriale, i periodi di ripresa della produttività, secondo rilevatori quantitativi e qualitativi, con ricadute positive sulla demografia e sugli indici igienici, sono spesso collegati con una particolare tecnica agronoma che lascia una porzione del terreno a maggese, cioè a riposo; il terreno, non sollecitato da alcuna coltivazione per almeno un anno, rigenera le proprie sostanze minerali e chimiche, necessarie a sostenere le coltivazioni successive. Nelle economie industriali-mercantili il rapporto con le risorse è mediato da una serie di passaggi successivi; le risorse, che comunque rimangono alla base dei processi di produzione-distribuzione, diventano evanescenti; la necessità di preservarle, un optional. I processi produttivi hanno raggiunto fin dal secolo scorso, livelli altissimi di complessità; diventano ingovernabili alla coscienza individuale. Auswitz morfologicamente è uno stabilimento produttivo, per questo fino al 1945 il Reich nazista è riuscito forse a dissimularne la vera funzione; ad Auswitz erano impiegati con funzioni amministrative anche civili; quando furono messi di fronte all'orrore, dichiararono di aver svolto semplicemente il loro lavoro e di non aver saputo niente. Posso credere a questa dichiarazione : quanti lavoratori del metallurgico sanno che i componenti prodotti nel loro stabilimento saranno montati in oggetti letali; o più banalmente, quanti di noi sanno concretamente di che cosa è fatto il cibo che si compra al supermercato? Quante delle vittime dello Tzunami hanno mai riflettuto sul fatto che quel paradiso proprio perché artificiale, estraneo a quella natura e a quella cultura, avrebbe potuto diventare la loro tomba? Questa moderna Weltanschaung, si caratterizza per un tratto strutturale, ovvero la scissione delle cose: il consumo e i bisogni sono separati dalle risorse; il profitto è altro rispetto alla condizioni che lo generano; la sua etica è separata e indipendente dall' etica sociale, dall' etica umanistica. Solo una forma mentale teleologica, organizzata su un sistema valoriale escatologico, ovvero una mente formata sui criteri inaugurati dalle religioni metafisiche, può concepire questa visione del mondo. Non è un caso che proprio il manicheismo originario, fondato nel 3° sc. dopo Cristo in ambito iranico da Mani e rinvigorito nella cultura europea e cristiana dalla esperienza catara, avesse elaborato come precetto fondamentale l'astensione da ogni attività che richiedesse il contatto con la terra, con la meteria, ovvero in una prospettiva economice, dall'agricoltura. Agli adepti che aspiravano alla verità e alla purezza l'unica attività economica consentita era il commercio: attività che veicola, ma non manipola la materia. Dalla riforma protestante, secondo M. Weber, il capitalismo ha trovato una legittimazione nell'etica calvinista; il profitto,l'obiettivo verso cui è orientato il sistema, disloca nella linea del futuro la soddisfazione dei propri bisogni: il domani è ciò su cui si investe il benessere, non la contingenza, il presente, il qui e ora, che spesso vengono ignorati. La recente riflessioni filosofica mette in evidenza i limiti della civiltà contemporanea, ad esempio la assoluta mancanza di responsabilità nei confronti della vita non umana – animale, vegetale, minerale - ; oppure, per quanto riguarda l'etica più specificatamente cristiana, la legittimazione del dolore, come garanzia di un premio successivo; si tratta di limiti concreti che potrebbero risolversi in scenari futuri insostenibili per l'uomo, per la sua vita e per la sua coscienza. Non è possibile certo rinnegare una identità che si è definita in secoli di produzione e trasmissione culturale; è possibile però riflettere su questa identità, metterla magari in discussione, laddove presenti lacune e limiti; è infine possibile integrarla con confronti e dialogo con altre possibilità. La cultura antica, primordiale di cui la Grande Madre si può assumere come archetipo emblematico, può costituire per noi contemporanei una identità alternativa, per altro mai definitivamente scomparsa dalla nostra mente, con cui confrontarci. Cosa ci insegna questa cultura? Essa in prima istanza propone una percezione dell'uomo, non come entità scissa, bensì contigua con il resto del mondo, per cui la tutela della cose non può che tradursi come tutela della vita umana. Essa ci insegna ancora ad accettare e a convivere con la morte, con il dolore, la sofferenza intese non già come come frustrazione di aspettative insoddisfatte, ma come momento fondante della ciclica metamorfosi della vita. L'orrore della morte non si traduce con l'illusione di una vita eterna, ma con il rispetto della vita.
e allora... buona navigazione, o Navigatore!
