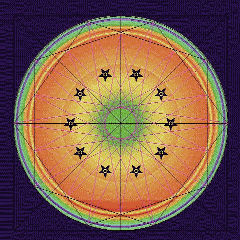Il Sacro Graal è l'asso di coppe
Mille anni dopo la sua nascita, la leggenda del Graal sta tornando in auge più che mai. Ignorando, però, piuste di ricerca molto interessanti
Nella simbologia del Graal alcuni vedono il richiamo ai riti di fecondità di una protoreligione che ha lasciato tracce in tutta la cultura aria. Questi riti, dall'India ai misteri greci, sono basati sulla ricorrenza di una coppa, una lancia, una pietra e una spada.
Temi che possono ben essere alla radice della simbologia presente sui tarocchi e sulle carte da gioco Mille anni dopo la sua nascita, la leggenda del Graal sta tornando in auge più che mai. Ma con connotazioni sbagliate, e ignorando piste di ricerca molto più interessanti ERRICO BUONANNO E' senza dubbio straordinario vedere come, in giorni in cui il mito del Graal, ad un millennio dalla propria formazione, sta ritornando in auge con un'invadenza spropositata e un'idiozia tutta moderna; giorni in cui le interpretazioni fantasiose, i best-seller tascabili, i progetti cinematografici anti-papisti e miliardari stanno galvanizzando i sogni popolari, spingendo torme di turisti e paladini verso la Rosslyn Chapel in una nuova Cerca mistica della sacra coppa, pochi davvero siano quelli che si son presi la minima briga di andarsi a leggere, prima o dopo le elucubrazioni attuali, gli antichi testi che hanno formato la leggenda. Giacché, non lo dimentichiamo, il Graal non rappresenta affatto una storia cristiana nel senso canonico del termine, non appare in nessunissimo vangelo (e men che meno negli apocrifi, che i nuovi gnostici tanto amano citare senza leggere), ma è solo, esclusivamente un mito romanzo cantato da poeti bretoni e francesi distanti più di mille anni da Gesù Cristo e Maddalena.
Quanto ogni altro adoratore di romanzi, non siamo e non possiamo essere contro la Cerca in sé per sé, però, da buoni cavalieri erranti, fuggiamo dalle false piste come da opere del Maligno. Dunque torniamo indietro al punto di partenza e finiremo finalmente, e in anteprima, per localizzare il vero luogo dove, in effetti, tuttora si nasconde la santa reliquia.
Sempre la stessa vicenda.
Il libro del Graal di Robert de Boron, il Percefal di Chrétien de Troyes, quello di Wauchier e di Manessier e tutti gli altri testi originari parlano, invariabilmente, di una stessa vicenda essenziale.
Galaad, Gawain, Parsifal o il cavaliere vergine di turno partono un giorno per una missione iniziatica, il più delle volte senza nemmeno saper bene che cosa mai stiano cercando. E' così che, in un tempo breve, giungono presso la Terra Desolata (la stessa di Eliot), un luogo dove la vegetazione e i fiumi si sono misteriosamente seccati a seguito dell'ammalarsi - o del cadere in uno strano stato di morte apparente - del mitico Re Pescatore, signore di quella provincia.
Presso il castello del sovrano, il cavaliere in questione dovrà dimostrarsi meritevole di poter ricevere in consegna il Graal, la coppa mistica che, sempre unita alla sacra lancia di Longino, saprà ridonare salute e giovinezza alla terra e al suo re. Bene, tant'è. Uno scrittore americano di successo ha concluso da questa vicenda che Gesù Cristo diede un figlio a Maddalena ed avviò una stirpe in Francia, i Merovingi, che sarebbero tuttora i reali detentori del trono di Davide.
Un poco più prosaicamente, circa ottant'anni fa, Jessie L. Weston, nel suo bellissimo From Ritual to Romance (disponibile per Sellerio sotto il titolo più pop di Indagine sul Santo Graal), individuò nella simbologia del racconto un rito di fecondità che affonderebbe le proprie radici in quella religione preistorica ipotizzata da Frazer nel suo Ramo d'oro e di cui dunque si potrebbero trovare tracce in tutta la cultura aria.
Non solo: la Weston s'impegnò a dimostrare come i suddetti riti, dall'India dei Rig-Veda fino ai misteri greci, siano basati sulla ricorrenza di quattro temi o simboli immutabili: una coppa, una lancia, una pietra e una spada. È con la danza delle spade che in India s'invoca da sempre la stagione fertile, così come succede nell'Italia del sud, ed è col dono di una coppa al giovane guerriero che in oriente si festeggia la sua entrata nell'età sessualmente feconda. Allo stesso modo, il Re Pescatore (secondo il simbolo ittiologico che ovunque significa luce e potenza vitale), colui che lega la propria salute alla fertilità della terra, colui che muore e risorge e ringiovanisce grazie alla coppa "sessualmente" fecondata dal sangue della lancia, nasconde una simbologia solare fin troppo evidente. A riti della fertilità, quella umana e quella della terra, sono connesse infatti divinità diverse ma tutte dal destino simile: così il Tammuz babilonese, l'Attis frigio, l'Adone greco e l'indio Indra. L'amante di Afrodite Il mito di Adone - vicenda gemella delle altre tre - è molto noto: splendido amante di Afrodite, morì a seguito della ferita infertagli da un cinghiale (ferita che veniva ascritta ai genitali nella versione più antica, proprio come quella del Re Pescatore nella gran parte dei testi). La terra si secca, i ruscelli si prosciugano, ma presto i pianti di Afrodite muovono a compassione la dea degli inferi Persefone, che consente così al giovane di ritornare in terra per metà dell'anno, facendo fruttificare il mondo. Ancora oggi, in molte zone dell'Europa, il passaggio di stagione viene celebrato con riti che riprendono in tutto e per tutto le antiche celebrazioni per Tammuz o quelle per Adone-Attis: in primav
Sempre la stessa vicenda
Il libro del Graal di Robert de Boron, il Percefal di Chrétien de Troyes, quello di Wauchier e di Manessier e tutti gli altri testi originari parlano, invariabilmente, di una stessa vicenda essenziale. Galaad, Gawain, Parsifal o il cavaliere vergine di turno partono un giorno per una missione iniziatica, il più delle volte senza nemmeno saper bene che cosa mai stiano cercando. E' così che, in un tempo breve, giungono presso la Terra Desolata (la stessa di Eliot), un luogo dove la vegetazione e i fiumi si sono misteriosamente seccati a seguito dell'ammalarsi - o del cadere in uno strano stato di morte apparente - del mitico Re Pescatore, signore di quella provincia. Presso il castello del sovrano, il cavaliere in questione dovrà dimostrarsi meritevole di poter ricevere in consegna il Graal, la coppa mistica che, sempre unita alla sacra lancia di Longino, saprà ridonare salute e giovinezza alla terra e al suo re.
Bene, tant'è. Uno scrittore americano di successo ha concluso da questa vicenda che Gesù Cristo diede un figlio a Maddalena ed avviò una stirpe in Francia, i Merovingi, che sarebbero tuttora i reali detentori del trono di Davide. Un poco più prosaicamente, circa ottant'anni fa, Jessie L. Weston, nel suo bellissimo From Ritual to Romance (disponibile per Sellerio sotto il titolo più pop di Indagine sul Santo Graal), individuò nella simbologia del racconto un rito di fecondità che affonderebbe le proprie radici in quella religione preistorica ipotizzata da Frazer nel suo Ramo d'oro e di cui dunque si potrebbero trovare tracce in tutta la cultura aria. Non solo: la Weston s'impegnò a dimostrare come i suddetti riti, dall'India dei Rig-Veda fino ai misteri greci, siano basati sulla ricorrenza di quattro temi o simboli immutabili: una coppa, una lancia, una pietra e una spada.
È con la danza delle spade che in India s'invoca da sempre la stagione fertile, così come succede nell'Italia del sud, ed è col dono di una coppa al giovane guerriero che in oriente si festeggia la sua entrata nell'età sessualmente feconda. Allo stesso modo, il Re Pescatore (secondo il simbolo ittiologico che ovunque significa luce e potenza vitale), colui che lega la propria salute alla fertilità della terra, colui che muore e risorge e ringiovanisce grazie alla coppa "sessualmente" fecondata dal sangue della lancia, nasconde una simbologia solare fin troppo evidente. A riti della fertilità, quella umana e quella della terra, sono connesse infatti divinità diverse ma tutte dal destino simile: così il Tammuz babilonese, l'Attis frigio, l'Adone greco e l'indio Indra.
L'amante di Afrodite
Il mito di Adone - vicenda gemella delle altre tre - è molto noto: splendido amante di Afrodite, morì a seguito della ferita infertagli da un cinghiale (ferita che veniva ascritta ai genitali nella versione più antica, proprio come quella del Re Pescatore nella gran parte dei testi). La terra si secca, i ruscelli si prosciugano, ma presto i pianti di Afrodite muovono a compassione la dea degli inferi Persefone, che consente così al giovane di ritornare in terra per metà dell'anno, facendo fruttificare il mondo. Ancora oggi, in molte zone dell'Europa, il passaggio di stagione viene celebrato con riti che riprendono in tutto e per tutto le antiche celebrazioni per Tammuz o quelle per Adone-Attis: in primavera, coppe ricolme di semi, i "Giardini di Adone", vengono abbandonate nelle acque dei ruscelli, mentre l'arrivo dell'inverno vede simbolici funerali del Re della Bella Stagione accompagnati da donne in lacrime che ne invocano la resurrezione, poiché se il re è morto anche la terra sarà appunto "desolata". Allo stesso modo, è forse bene ricordare che nella gran parte delle versioni arturiane, dal Diû Crône al Lancelot, la "processione del Graal" è composta da donne che, senza alcuna coerenza o motivo apparente, piangono e si lamentano portando la coppa.
Ma andiamo avanti. Lasciando la Weston, i miti celtici raccontano che in Irlanda, tra altre popolazioni immaginarie, abitavano i divini Tuatha de Danann, la "gente di Danu" provenuta dalla Terra Lontana.
I doni per gli umani
Quando sull'isola arrivarono i primi Celti (la "gente di Varie http://www.inavigatori.eu/varie/idx_varie_0006.htm I Navigatori http://www.inavigatori.eu/navigatori/idx_inavigatori_0001.htm Il Manifesto http://www.ilmanifesto.it/ Mil", ovverosia i Gaeli) i Danu se ne andarono, lasciando in dono agli umani oggetti magici e preziosi: la lancia di Lug, il dio del sole, che i Gallesi chiamavano Lleu; la spada di Nuadu, il re dalla mano d'argento; la pietra o menhir di Fal, la "Pietra del destino"; e soprattutto la coppa di Dagda, la "Coppa della conoscenza" che in altri miti assunse la forma di calderone (come quello della dea madre Keridwen o quello più comune delle streghe-dee della terra) ovvero di una sorta di cornucopia dell'abbondanza.
Questi regali manifestamente alchemici, queste chiavi per la dominazione delle quattro stagioni, dei quattro elementi e della fecondità di cui i Danu erano signori, si estesero nell'immaginario delle popolazioni celtiche sul continente. Ce lo ricorda A.C.L. Brown nel suo The Bleeding Lance: presso i Britanni è attorno ad una pietra-menhir circolare che si riuniscono i paladini arturiani - la cosiddetta tavola rotonda - ed è in una pietra che è conficcata la spada Excalibur; è alla ricerca di una coppa che va Parsifal, ma questa coppa è sempre assieme ad una lancia sanguinante; tutti elementi che il sostrato cristiano contaminò con attribuzioni del tutto superficiali. La coppa diviene così quella in cui Giuseppe d'Arimatea raccoglie il sangue del Cristo e la lancia di Lug o di Lleu quella con cui Longino ferisce il costato del Salvatore (personaggi ed episodi anch'essi del tutto assenti dai vangeli canonici). Ma a questo punto vale la pena quantomeno di citare tutto l'intreccio di simboli di cui lo stesso Graal diviene oggetto: nella versione duecentesca di Wolfram von Eschenbach, questo cessa di essere una coppa proprio per divenire una pietra, mentre frequente è la sua raffigurazione a mo' di piatto, rotondo come la tavola-menhir, circolare e d'oro come l'elemento di Lug, il sole, le monete, gli amuleti.
Tradizioni giudaiche e pagane
È forse inutile accennare alle tradizioni giudaiche e pagane legate al ritorno dell'età dell'Oro, o l'importanza del culto solare e mitraico nella genesi del cristianesimo. Ci basterà qui ricordare, assieme a Zolla, l'ascensione biblica del profeta Elia. San Giovanni Crisostomo lo chiama più esplicitamente Helio, e a questo punto il quadro è chiaro: Elia, nel simbolo, non è altri che Helios, il sole appunto, che ascende su un carro di fuoco. Egli nasce - sarà un caso - a Tisbe, in Galaad, e proprio Galaad sarà l'eroe degno del Graal, il piatto d'oro o astro solare, colui che col Sangue redentore della lancia di Longino-Lug guarirà i campi essiccati.
Il sole, il ciclo delle stagioni, le coppe dell'abbondanza: elementi primitivi rintracciabili ovunque, frutto di religioni ancestrali legate al culto primigenio della Terra. È questa la simbologia più elementare, più naturale ma non per questo meno affascinante che i cantori del Graal hanno magari inconsciamente raccolto.
Stiamo per terminar la Cerca: ci basterà ora scoprire dove si sia nascosta oggi la coppa mistica della giovinezza, assieme ai suoi tre oggetti-simbolo compagni. A tal proposito ricordiamo che, nell'est Europa, divinazioni sulla fecondità e i cicli dell'acqua (che solo più tardi assunsero il carattere di divinazioni sul futuro in genere) venivano fatte attraverso disegni magici di re e di cavalieri e altri, i "Trionfi", che, sempre in forma quaternaria, rappresentavano delle spade o picche (fuoco), dei cuori o coppe (acqua), bastoni o quadri (terra) e alcuni simboli di aria dalla forma varia, circolari come soli, o come tavole rotonde, o come piccole monete. Presto, attraverso le popolazioni rom, questi tarocchi penetrarono in Occidente creando quel "gioco del mondo", quel gioco mistico e sacrale degli elementi e delle stagioni: le nostre carte più comuni. La meta è raggiunta, la Cerca compiuta e, ritrovandoci tra le mani le ultime raffigurazioni della Lancia di Longino e della tavola arturiana, o quelle della spada Excalibur, sarà con un sorriso più conscio, più santo e fecondo che ammireremo nell'iconografia di un asso di coppe il vero, autentico e ritrovato Graal.
e allora... buona navigazione, o Navigatore!